Nel 2018 in Italia si sono giocati quasi 107 miliardi di euro. Ma se i più ricchi restano sui giochi tradizionali, sono i più poveri a dedicarsi a scommesse e slot-machine. I risultati di uno studio sugli effetti distributivi del gioco d’azzardo.
Il boom dell’azzardo
Secondo gli ultimi dati dell’Agenza delle dogane e dei monopoli, nel 2018 in Italia si sono giocati 106,7 miliardi di euro (Adm, 2019). Una cifra quasi assimilabile al fondo sanitario nazionale per il 2018 (che vale circa 113 miliardi) è stata investita nel gioco d’azzardo. Tra il 2000 e il 2018 si è passati da una raccolta di 19 miliardi di euro a quasi 107.
L’incremento esponenziale è stato accompagnato da un processo di riforma che ha considerevolmente liberalizzato il mercato aumentando l’offerta di prodotti: la legge n. 289 del 2002 ha aperto le porte dei pubblici esercizi alle slot machine, nel 2006 il decreto legge n. 248 (cosiddetto Bersani-Visco) ha rimosso le barriere all’accesso degli operatori stranieri, c’è stata poi la liberalizzazione delle Vlt (videolottery) con il decreto legge 39/2009 (cosiddetto decreto Abruzzo) e quella del gioco online con il decreto legge n. 138/2011 (cosiddetto di Ferragosto).
La proliferazione dei giochi ha fatto aumentare non solo la raccolta, ma anche il numero di giocatori problematici. Sulla base del Canadian Problem Gambling Index (Cpgi), la prevalenza di giocatori problematici nella popolazione italiana (15-64 anni) stimata dallo studio Ipsad (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs) dell’Istituto di fisiologia clinica del Cnr, è salita da 0,33 per cento nel 2007 a 1,04 per cento nel 2017 (Ifc-Cnr, 2018). Nel 2017, l’emergere della problematica ha spinto il governo a includere la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da ludopatia nei Lea (livelli essenziali di assistenza) in seguito alla legge n. 189 del 2012.
Ma chi sta pagando?
Per studiare gli effetti del boom del gioco d’azzardo sulla società, è utile distinguere tra i diversi giochi presenti oggi sul mercato italiano. L’Ufficio parlamentare di bilancio individua tre categorie: giochi tradizionali (lotterie, Lotto, giochi numerici a totalizzatore e Bingo), scommesse (gioco a base sportiva, gioco a base ippica, scommesse virtuali) e giochi di nuova generazione (Awp-amusement with prizes, Vlt, giochi di carte e di abilità a distanza e giochi di sorte a quota fissa, betting exchange).
La categorizzazione permette di osservare che l’aumento della raccolta degli ultimi anni è in realtà riconducibile quasi esclusivamente ai giochi di nuova generazione e alle scommesse. Una importante differenziazione tra questi prodotti da gioco si osserva nel payout (la quota di giocate che rientra ai giocatori sotto forma di vincite). Quello medio delle lotterie tradizionali è del 67 per cento, quello delle scommesse è dell’86 per cento e quello dei giochi di nuova generazione è dell’84 per cento. Queste categorie si differenziano anche in termini di problematicità. I nuovi giochi e le scommesse sportive attirano quote di giocatori problematici significativamente più alte dei giochi tradizionali.
Un nostro recente studio mette in luce, per la prima volta, gli effetti distributivi del boom del gioco d’azzardo in Italia stimando l’indice di Erreygers – una misura di disuguaglianza specifica dell’economia sanitaria – sui dati Ipsad 2014 e 2017.
Ipsad è uno studio di prevalenza sull’uso di alcol e altre sostanze psicoattive lecite e illecite, rappresentativo della popolazione generale italiana, condotto con cadenza regolare. Da più di dieci anni monitora anche la diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo e le caratteristiche individuali che vi sono associate. L’indice Erreygers permette di stimare quanto la distribuzione di una caratteristica individuale specifica, come l’attività di gioco d’azzardo, si allontana da una distribuzione neutrale rispetto al reddito. Un indice di Erreygers positivo (negativo) indica che la caratteristica individuale oggetto dell’analisi è concentrata tra gli individui con reddito più alto (più basso).
I risultati mostrano che i giochi tradizionali sono più praticati da persone a reddito più alto, mentre le scommesse sportive e i giochi di nuova generazione sono più diffusi tra quelle a reddito più basso. Dunque, l’aumento della raccolta, derivato in gran parte proprio dai nuovi giochi e dalle scommesse, lo stanno pagando i soggetti più svantaggiati. E dal momento che le scommesse e i giochi di nuova generazione sono anche quelli più fortemente associati a comportamenti di gioco problematico, possiamo ragionevolmente ipotizzare che i crescenti costi sociali dei disturbi del gioco d’azzardo in Italia ricadano di più proprio sul segmento più vulnerabile della nostra società.
Scomponendo la disuguaglianza economica osservata nella ricerca dei fattori che la guidano, emerge che una quota rilevante è attribuibile al genere, all’età (sono soprattutto i giovani senza reddito quelli che giocano a nuovi giochi e scommesse), all’istruzione (persone maggiormente istruite giocano di meno e allo stesso tempo hanno redditi più alti), alla posizione lavorativa (i disoccupati e gli studenti giocano di più a giochi più diffusi tra poveri) e geografica (al Sud si gioca di più, ma le persone hanno un reddito più basso).
I nostri risultati evidenziano l’importanza di investire in istruzione e in programmi di prevenzione specifici per limitare la diffusione della dipendenza da gioco. A questo scopo, potrebbe essere opportuna anche una rimodulazione del payout che aumenti l’incidenza fiscale sui giochi più pericolosi, politica che ha già mostrato risultati nello scoraggiare comportamenti a rischio associati ad altri “beni del peccato” (sin goods), come il tabacco e l’alcol. La politica discute una rimodulazione della tassazione sui giochi, ma le proposte fatte finora si rivolgono in maniera omogenea a tutti i tipi di gioco e riguardano solo i premi. Provvedimenti di questo tipo lasciano al giocatore l’illusione di un payout alto: avrebbero chiaramente un ruolo ridistributivo, rischiano tuttavia di non disincentivare i comportamenti a rischio legati al gioco d’azzardo.
Lavoce è di tutti: sostienila!
Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

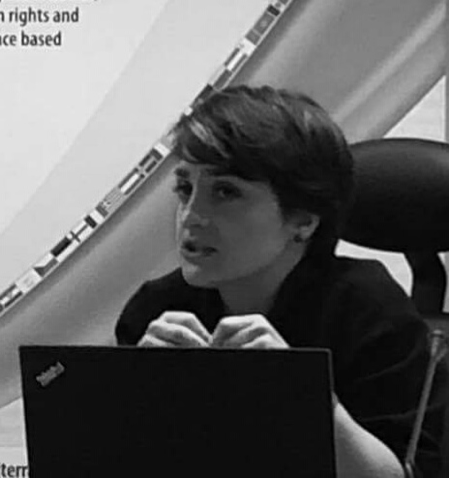 Elisa Benedetti è ricercatrice presso l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR). La sua esperienza lavorativa include collaborazioni con enti pubblici in Italia e organizzazioni internazionali a Bruxelles in materia di politiche pubbliche e organizzazione sanitaria. Laureata in Scienze Politiche all’Università di Pisa, sta attualmente conseguendo il dottorato in Economics presso le Università di Siena, Firenze e Pisa. I suoi interessi riguardano principalmente la valutazione di politiche pubbliche in materia di droghe e gioco d’azzardo.
Elisa Benedetti è ricercatrice presso l’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR). La sua esperienza lavorativa include collaborazioni con enti pubblici in Italia e organizzazioni internazionali a Bruxelles in materia di politiche pubbliche e organizzazione sanitaria. Laureata in Scienze Politiche all’Università di Pisa, sta attualmente conseguendo il dottorato in Economics presso le Università di Siena, Firenze e Pisa. I suoi interessi riguardano principalmente la valutazione di politiche pubbliche in materia di droghe e gioco d’azzardo. Raffaele Lagravinese è Professore Associato in Economia Politica presso il Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Bari “A. Moro”. I suoi principali interessi di ricerca riguardano, le disuguaglianze territoriali, le politiche di sviluppo regionali e l’economia sanitaria.
In passato ha svolto periodi di ricerca presso le Università di Cambridge e York. Ha insegnato a contratto corsi di economia presso le Università di Roma Tre e Brunel Business School di Londra.
Raffaele Lagravinese è Professore Associato in Economia Politica presso il Dipartimento di Economia e Finanza, Università di Bari “A. Moro”. I suoi principali interessi di ricerca riguardano, le disuguaglianze territoriali, le politiche di sviluppo regionali e l’economia sanitaria.
In passato ha svolto periodi di ricerca presso le Università di Cambridge e York. Ha insegnato a contratto corsi di economia presso le Università di Roma Tre e Brunel Business School di Londra.
 Sabrina Molinaro è Responsabile della Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari, Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR)
Progetta, attiva e coordina studi e ricerche epidemiologiche sulla popolazione generale e su popolazioni specifiche con focus mirati su popolazioni nascoste (tossicodipendenti, ecc). Si dedica alla progettazione di studi clinici per la valutazione di efficacia ed efficienza dei percorsi terapeutici e degli outcome trattamentali; in questo ambito ha sviluppato modelli di analisi statistico-epidemiologica di grandi quantità di dati (flussi sanitari standard), allo scopo di utilizzare l’informazione per la programmazione strategica delle politiche di governance sanitaria. Ha inoltre attivato un filone di ricerca e di trasferimento tecnologico nell’ambito della Medicina Personalizzata, con particolare riferimento a nuovi strumenti di data mining e sviluppo di modelli di previsione clinici e sanitari. Collabora con l’European Monitoring Center of Drug and Drug abuse (EU Commission).
Sabrina Molinaro è Responsabile della Sezione di Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari, Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR)
Progetta, attiva e coordina studi e ricerche epidemiologiche sulla popolazione generale e su popolazioni specifiche con focus mirati su popolazioni nascoste (tossicodipendenti, ecc). Si dedica alla progettazione di studi clinici per la valutazione di efficacia ed efficienza dei percorsi terapeutici e degli outcome trattamentali; in questo ambito ha sviluppato modelli di analisi statistico-epidemiologica di grandi quantità di dati (flussi sanitari standard), allo scopo di utilizzare l’informazione per la programmazione strategica delle politiche di governance sanitaria. Ha inoltre attivato un filone di ricerca e di trasferimento tecnologico nell’ambito della Medicina Personalizzata, con particolare riferimento a nuovi strumenti di data mining e sviluppo di modelli di previsione clinici e sanitari. Collabora con l’European Monitoring Center of Drug and Drug abuse (EU Commission). Giuliano Resce è Professore Associato di Economia Politica presso l’Università del Molise. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze, PhD in Economia presso l’Università di Roma Tre. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente lo studio dell’equità e dell’efficienza nel settore pubblico. Ha lavorato per l’Università di Firenze, per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per SOSE SpA, ed è stato Visiting Fellow presso London School of Economics, ETH Zürich, University of Sheffield, University of Portsmouth, e World Bank. È stato consulente per IFAD, Commissione Europea e Fondo Europeo per gli Investimenti. Ha fatto parte del gruppo di esperti per il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attualmente è consulente per il Centro Internazionale per l'Agricoltura Tropicale e Fondazione IFEL ANCI.
Giuliano Resce è Professore Associato di Economia Politica presso l’Università del Molise. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze, PhD in Economia presso l’Università di Roma Tre. I suoi interessi di ricerca riguardano principalmente lo studio dell’equità e dell’efficienza nel settore pubblico. Ha lavorato per l’Università di Firenze, per il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per SOSE SpA, ed è stato Visiting Fellow presso London School of Economics, ETH Zürich, University of Sheffield, University of Portsmouth, e World Bank. È stato consulente per IFAD, Commissione Europea e Fondo Europeo per gli Investimenti. Ha fatto parte del gruppo di esperti per il Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attualmente è consulente per il Centro Internazionale per l'Agricoltura Tropicale e Fondazione IFEL ANCI.
Lascia un commento