La crisi sanitaria può trasformarsi in una recessione globale e minare la stabilità finanziaria. Serve una immediata risposta europea, con la costruzione di sistema di assicurazione comune e reciproca, che aiuti le imprese a superare il momento critico.
Il rischio sistemico dovuto al coronavirus
Dall’inizio dell’anno Covid-19, un nuovo virus, si sta diffondendo a livello globale, creando la percezione di una pandemia incontrollata che potrebbe cambiare le nostre vite. La conseguente riduzione dell’attività economica in tutto il mondo minaccia di causare una recessione globale e di danneggiare la stabilità finanziaria. Diversi governi hanno imposto norme rigorose per evitare contatti non necessari con persone già infette, per proteggere le fasce vulnerabili della popolazione. Ciò ha portato alla chiusura di scuole, università e aziende, gettando un’ombra sulla situazione internazionale come non si vedeva da decenni.
Le implicazioni per l’attività economica – produzione e, su scala crescente, consumo – sono gravi. Una volta esaurite le scorte, la produzione dovrà rallentare, con conseguenze a catena su tutta la filiera produttiva. Il settore dei servizi è tra i più colpiti, in particolare turismo e intrattenimento. L’ansia tra i consumatori condizionerà pesantemente il consumo individuale e di conseguenza i ricavi delle imprese.
Contrariamente al crollo del mercato finanziario del 2008, il settore reale è stato colpito a livello globale, a causa dell’elevato grado di interconnessione della produzione e della distribuzione in tutto il mondo. L’interruzione dell’attività economica all’inizio causa problemi di liquidità a privati, imprese e banche, ma presto la loro interconnessione potrebbe trasformare il problema di liquidità in un problema di solvibilità per le ultime due categorie.
Con una riduzione dei flussi di cassa, le aziende avranno infatti difficoltà a pagare i propri fornitori e i dipendenti ma anche a ripagare i prestiti delle banche, anche quando i loro modelli di business sono solidi. Tuttavia la caduta della produzione indotta dal coronavirus è un evento temporaneo e non uno dirompente e di lungo termine come la crisi finanziaria del 2008: una volta che l’epidemia si sarà fermata, è probabile che i guadagni ritornino ai livelli normali. In un mondo ideale, dunque, l’epidemia dovrebbe dar luogo a un problema di liquidità, non di redditività a lungo termine per le imprese. In realtà, però, le informazioni si diffondono in modo imperfetto e alcune aziende possono vedersi negato l’accesso ai finanziamenti; la riduzione della liquidità si trasforma così in un problema di solvibilità, fino a causare il fallimento di imprese che pure sono redditizie.
In Europa, le banche sono i principali creditori e dovrebbero creare accantonamenti per coprire eventuali perdite sui crediti, con riflessi sulla loro adeguatezza patrimoniale. Lo stiamo già vedendo in Italia, dove le banche hanno iniziato a concedere moratorie sui prestiti in essere, per evitare il default delle imprese. Tuttavia, il contagio potrebbe allargarsi ai governi che cercano di offrire un piano di salvataggio alle banche (oltre al sostegno diretto a imprese e privati). Se un paese ha già elevati livelli del debito sovrano, anche la sua capacità di finanziamento è limitata e si potrebbe innescare una spirale perversa tra rischio sovrano, rischio bancario e ancora rischio sovrano (doom loop) come nel 2011.
La situazione creata del virus non è paragonabile alla crisi dell’euro del 2011, perché la crisi di oggi è dovuta a uno shock esogeno e ciò dovrebbe ridurre le preoccupazioni di azzardo morale. Tuttavia la potenziale situazione di crisi nel sistema bancario potrebbe essere esacerbata anche dal comportamento dei correntisti. In assenza di un’assicurazione sui depositi europea credibile, potrebbero esserci dubbi sulla capacità di resistenza del sistema bancario e ciò potrebbe causare una corsa agli sportelli (bank run).
La risposta che l’Europa deve dare
Per tutte queste ragioni, la crisi sanitaria potrebbe trasformarsi in una vera e propria crisi bancaria. L’epidemia di coronavirus crea dunque un rischio sistemico, che potrebbe evolvere persino in un fenomeno globale. Lo si può contrastare solo dando il via a una forma di regime di assicurazione comune e reciproca, che permetta di compensare le imprese per le carenze di flusso di cassa indotte dalla crisi (e non da pregressi problemi propri) e che quindi limiti (o eviti) gli effetti a catena su produzione, consumo, attività bancaria e rischio sovrano.
È necessario un intervento urgente a livello europeo, perché la realizzazione di una assicurazione comune è di sicuro complessa. Se il tentativo fallisce, è molto probabile che ben presto ci troveremo di fronte a una nuova crisi finanziaria. Ma, se ben gestita, questa azione comune di “solidarietà” europea può portare a una condivisione del rischio che renda sostenibile l’Unione bancaria europea e mantenga la solidarietà senza azzardo morale.
I governi hanno già avviato azioni politiche e finanziarie per stabilizzare l’economia. Vari paesi – e le loro banche centrali – lavorano a misure volte a mitigare i danni per la crescita globale. La Banca centrale europea ha appena adottato provvedimenti per mantenere la necessaria liquidità sui mercati e si è dichiarata disponibile a usare la massima flessibilità, ma ha sottolineato la necessità di misure fiscali forti e coordinate da parte di governi nazionali e istituzioni europee.
La nostra analisi suggerisce un’azione fiscale congiunta, lasciando un ruolo più limitato alla politica monetaria (per esempio, l’acquisto di titoli sovrani per ridurre il costo del finanziamento dei diversi stati europei). Di fronte all’incombente insolvenza di imprese e privati, è improbabile che strumenti monetari come i tassi di interesse o gli acquisti di attività siano in grado di risolvere da soli il problema, dato che la crisi di liquidità si accompagna alla necessità delle banche di soddisfare i requisiti di capitale.
Quello di cui c’è assoluta necessità in questo momento è un intervento rapido e mirato che garantisca liquidità alle imprese che devono far fronte a interruzioni della produzione e della loro catena di approvvigionamento e a quelle che si trovano affrontare un repentino calo della domanda. L’attuale sfida per l’Europa ha due dimensioni: trovare strumenti adeguati per misurare rapidamente la carenza di flussi di cassa a livello aziendale e trovare un modo per incanalare fondi verso le persone, le imprese e le banche interessate.
Un modo collaudato e affidabile per raggiungere le aziende in modo diretto e mirato è attraverso i sistemi Kurzarbeit, che sono ben consolidati in Germania e che corrispondono alla cassa integrazione in Italia. In tali sistemi le imprese con carenze di liquidità possono esternalizzare temporaneamente parte dei salari, oltre all’assicurazione contro la disoccupazione, finanziata con contributi previdenziali. Pertanto, per un periodo limitato, vi è la condivisione del rischio di occupazione tra i lavoratori. A livello europeo tale sostegno potrà essere concordato solo se si riesce a evitare l’azzardo morale, in altre parole se si riesce a evitare che imprese già vicine al fallimento (zombie firms) ne approfittino per ricevere i sussidi: è una condizione preliminare affinché il sistema sia economicamente efficiente e politicamente accettabile. Un indicatore oggettivo per concedere i sussidi potrebbe essere il pagamento dell’Iva nell’anno precedente: in questo modo si eviterebbe di finanziare le imprese decotte e quelle che nel passato poco hanno contribuito alle entrate dello stato magari perché evasori.
Le banche di sviluppo statali in Europa possono fungere da canali per raggiungere le imprese ammissibili, come già sta facendo in Italia la Cassa depositi e prestiti. Le istituzioni finanziarie sovranazionali, in particolare la Banca per gli investimenti europei e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, attraverso il loro accesso alle banche e ai mercati dei capitali in tutta Europa, possono fornire i finanziamenti necessari. Il sistema, se applicato con successo, si configura come un ponte per affrontare il periodo di crisi, in modo da aiutare le imprese colpite ed evitare le inefficienze e la perdita di competenze e competitività dell’Europa che inevitabilmente si verificherebbe qualora queste imprese, in un breve periodo di tempo, fossero costrette al fallimento.
Lavoce è di tutti: sostienila!
Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

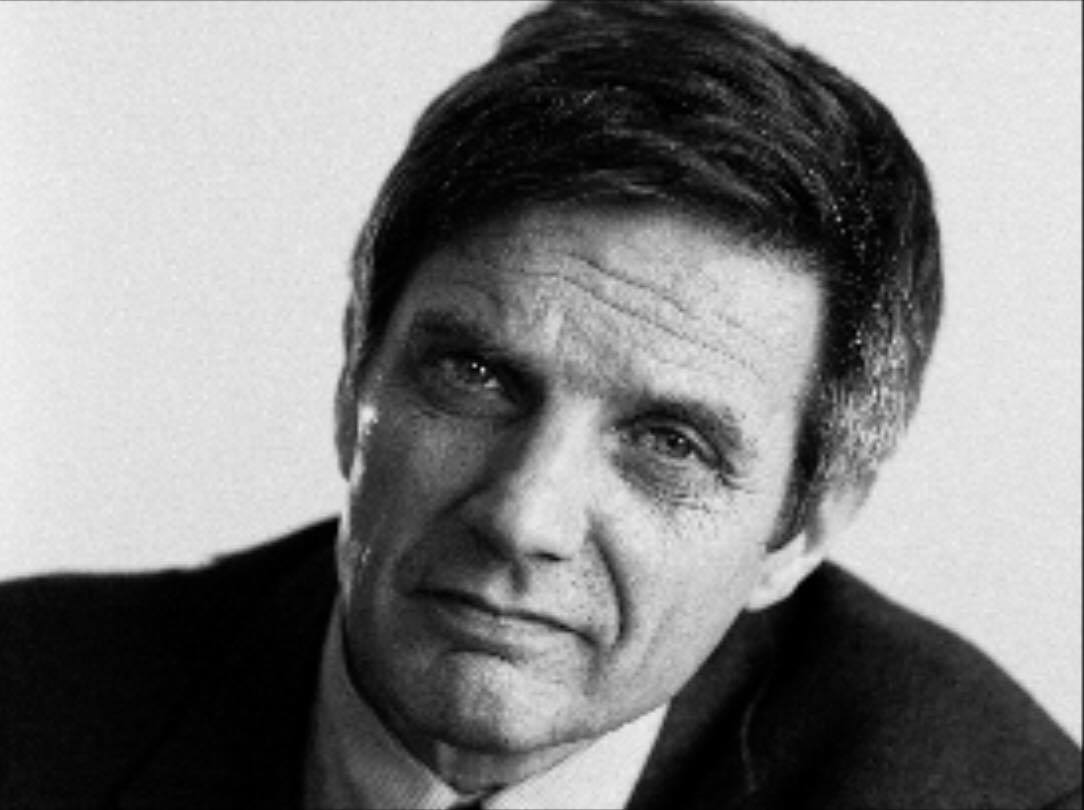 Arnoud Boot è professore di Finanza aziendale e mercati finanziari presso l'Università di Amsterdam e membro della Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). È presidente della European Finance Association (EFA) e ricercatore presso il Centro di ricerca di politica economica (CEPR) di Londra. Il professor Boot è anche membro della tavola rotonda degli economisti finanziari.
Arnoud Boot è professore di Finanza aziendale e mercati finanziari presso l'Università di Amsterdam e membro della Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW). È presidente della European Finance Association (EFA) e ricercatore presso il Centro di ricerca di politica economica (CEPR) di Londra. Il professor Boot è anche membro della tavola rotonda degli economisti finanziari. Professoressa ordinaria di Finanza all'Università Bocconi. In precedenza, è stata professoressa di economia presso l'Istituto universitario europeo, dove ha ricoperto la cattedra nel dipartimento di economia e nel Robert Schuman Center for Advanced Studies. Research Fellow presso CEPR, Extramural fellow presso TILEC, Fellow presso il Center for Financial Studies, al CESifo, all'IGIER e al Wharton Financial Institutions Centre. Membro del Consiglio di amministrazione in Unicredit, dove presiede il comitato per controlli interni e rischi, e membro del comitato scientifico consultivo dell’European Systemic Risk Board.
Professoressa ordinaria di Finanza all'Università Bocconi. In precedenza, è stata professoressa di economia presso l'Istituto universitario europeo, dove ha ricoperto la cattedra nel dipartimento di economia e nel Robert Schuman Center for Advanced Studies. Research Fellow presso CEPR, Extramural fellow presso TILEC, Fellow presso il Center for Financial Studies, al CESifo, all'IGIER e al Wharton Financial Institutions Centre. Membro del Consiglio di amministrazione in Unicredit, dove presiede il comitato per controlli interni e rischi, e membro del comitato scientifico consultivo dell’European Systemic Risk Board. Rainer Haselmann è Direttore del Centro di studi avanzati sulle basi di diritto e finanza. È professore di Finanza, contabilità e fiscalità all'Università Goethe di Francoforte, Centro di ricerca SAFE e CEPR Research Fellow.
Rainer Haselmann è Direttore del Centro di studi avanzati sulle basi di diritto e finanza. È professore di Finanza, contabilità e fiscalità all'Università Goethe di Francoforte, Centro di ricerca SAFE e CEPR Research Fellow. Hans-Helmut Kotz è ricercatore senior presso il Centro per gli studi finanziari (CFS) e direttore del programma del SAFE Policy Center. È Resident Fellow presso il Center di studi Europei dell'Università di Harvard. È anche membro della Facoltà di Economia dell'Università di Friburgo, dalla quale ha ricevuto il premio per l'insegnamento universitario nel 2010. Dal 2011 è consulente senior presso McKinsey. È membro del consiglio di sorveglianza di Eurex Clearing AG, Francoforte / Zurigo (dal 2013) e membro non esecutivo del consiglio di amministrazione di Caixa Geral de Depósitos, Lisbona (dal 2017).
Hans-Helmut Kotz è ricercatore senior presso il Centro per gli studi finanziari (CFS) e direttore del programma del SAFE Policy Center. È Resident Fellow presso il Center di studi Europei dell'Università di Harvard. È anche membro della Facoltà di Economia dell'Università di Friburgo, dalla quale ha ricevuto il premio per l'insegnamento universitario nel 2010. Dal 2011 è consulente senior presso McKinsey. È membro del consiglio di sorveglianza di Eurex Clearing AG, Francoforte / Zurigo (dal 2013) e membro non esecutivo del consiglio di amministrazione di Caixa Geral de Depósitos, Lisbona (dal 2017). Jan Pieter Krahnen è professore di finanza presso il Leibniz Institute SAFE dell'Università Goethe di Francoforte. È direttore del Centro per gli studi finanziari (CFS) e del Leibniz Institute SAFE. Il professor Krahnen è membro del gruppo di esperti ad alto livello sulle riforme strutturali del settore bancario dell'Ue ("Commissione Liikanen"), attuato dal commissario europeo Michel Barnier. Dal 2008 al 2012 è stato membro della Commissione Issing, fornendo consulenza al governo tedesco sugli incontri del G-20. Fino a poco tempo fa era anche membro del gruppo di cnsulenti economici (GEA) presso la European Securities and Markets
Agency (ESMA) di Parigi. Inoltre, è membro del Consiglio consultivo accademico del Ministero federale delle finanze tedesco.
Jan Pieter Krahnen è professore di finanza presso il Leibniz Institute SAFE dell'Università Goethe di Francoforte. È direttore del Centro per gli studi finanziari (CFS) e del Leibniz Institute SAFE. Il professor Krahnen è membro del gruppo di esperti ad alto livello sulle riforme strutturali del settore bancario dell'Ue ("Commissione Liikanen"), attuato dal commissario europeo Michel Barnier. Dal 2008 al 2012 è stato membro della Commissione Issing, fornendo consulenza al governo tedesco sugli incontri del G-20. Fino a poco tempo fa era anche membro del gruppo di cnsulenti economici (GEA) presso la European Securities and Markets
Agency (ESMA) di Parigi. Inoltre, è membro del Consiglio consultivo accademico del Ministero federale delle finanze tedesco. Loriana Pelizzon è Professoressa Ordinaria di Politica Economica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e di Diritto e Finanza presso il
Leibniz Institute SAFE dell'Università Goethe di Francoforte, dove è anche direttrice del Systemic Risk Lab. È autrice di numerosi articoli pubblicati sulle principali riviste di finanza a livello internazionale e ha vinto numerosi premi sia per la ricerca che per l’insegnamento. È coinvolta in diversi progetti Europei, è stata coordinatrice dell'Ente di dottorato dell'EFA e membro del comitato esecutivo. Fa parte del gruppo
di esperti indipendenti dell'UE nel settore dell'Unione bancaria ed è esperta per la commissione UE in materia di moneta digitale e della tecnologia blockchain. Dal 2018 è membro del Advisory Scientific Commitee dell’European Systemic Risk Board.
Loriana Pelizzon è Professoressa Ordinaria di Politica Economica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e di Diritto e Finanza presso il
Leibniz Institute SAFE dell'Università Goethe di Francoforte, dove è anche direttrice del Systemic Risk Lab. È autrice di numerosi articoli pubblicati sulle principali riviste di finanza a livello internazionale e ha vinto numerosi premi sia per la ricerca che per l’insegnamento. È coinvolta in diversi progetti Europei, è stata coordinatrice dell'Ente di dottorato dell'EFA e membro del comitato esecutivo. Fa parte del gruppo
di esperti indipendenti dell'UE nel settore dell'Unione bancaria ed è esperta per la commissione UE in materia di moneta digitale e della tecnologia blockchain. Dal 2018 è membro del Advisory Scientific Commitee dell’European Systemic Risk Board. Stephen Schaefer è stato membro della facoltà della Graduate School of Business dell'Università di Stanford. È stato anche visiting professor presso le Università della British Columbia, California (Berkeley), Città del Capo, Chicago e Venezia, dove ha recentemente ottenuto una Honorary Fellowship. Oggi è il principale direttore accademico dell'AQR Asset Management Institute della London Business School. È inoltre coautore di due importanti relazioni per il Ministero delle finanze norvegese sulla gestione del Fondo pensioni del governo norvegese (il "Fondo petrolifero"). È stato anche membro indipendente del consiglio di amministrazione di Securities and
Futures Authority; un consulente di ricerca senior del KMV di Moody; direttore non esecutivo di Leo Fund Management; amministratore fiduciario di Smith Breeden Mutual Funds e membro del Comitato consultivo e di ricerca accademica di Moody.
Stephen Schaefer è stato membro della facoltà della Graduate School of Business dell'Università di Stanford. È stato anche visiting professor presso le Università della British Columbia, California (Berkeley), Città del Capo, Chicago e Venezia, dove ha recentemente ottenuto una Honorary Fellowship. Oggi è il principale direttore accademico dell'AQR Asset Management Institute della London Business School. È inoltre coautore di due importanti relazioni per il Ministero delle finanze norvegese sulla gestione del Fondo pensioni del governo norvegese (il "Fondo petrolifero"). È stato anche membro indipendente del consiglio di amministrazione di Securities and
Futures Authority; un consulente di ricerca senior del KMV di Moody; direttore non esecutivo di Leo Fund Management; amministratore fiduciario di Smith Breeden Mutual Funds e membro del Comitato consultivo e di ricerca accademica di Moody. Marti Subrahmanyam è Professore Charles E Merrill, di economia e finanza presso la Leonard N Stern School of Business, New York University e professore di Finanza presso la NYU Shanghai. Ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica presso l'Indian Institute of Technology di Madras e un diploma post-laurea in amministrazione aziendale presso l'Indian Institute of Management di Ahmedabad. Entrambe le istituzioni gli hanno conferito il loro Distinguished Alumnus Award. È stato consulente di diverse società, gruppi industriali e istituzioni finanziarie negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e in America Latina. Ha servito o continua a far parte dei consigli di amministrazione di diverse società. È stato consulente di organizzazioni internazionali e governative e ha insegnato in oltre venti paesi in tutto il mondo. Il professor Subrahmanyam è consulente di diverse startup in India e negli Stati Uniti.
Marti Subrahmanyam è Professore Charles E Merrill, di economia e finanza presso la Leonard N Stern School of Business, New York University e professore di Finanza presso la NYU Shanghai. Ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica presso l'Indian Institute of Technology di Madras e un diploma post-laurea in amministrazione aziendale presso l'Indian Institute of Management di Ahmedabad. Entrambe le istituzioni gli hanno conferito il loro Distinguished Alumnus Award. È stato consulente di diverse società, gruppi industriali e istituzioni finanziarie negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e in America Latina. Ha servito o continua a far parte dei consigli di amministrazione di diverse società. È stato consulente di organizzazioni internazionali e governative e ha insegnato in oltre venti paesi in tutto il mondo. Il professor Subrahmanyam è consulente di diverse startup in India e negli Stati Uniti.
Federico Leva
Una proposta ragionevole: puntare all’assegno di disoccupazione europeo o agli eurobond è forse troppo, ma una cassa integrazione europea potrebbe essere un primo passo per ridurre l’impatto degli shock asimmetrici e dei doom loop. Un po’ come i TLTRO e gli APP incentrati sulle obbligazioni private, inoltre, può essere venduta all’opinione pubblica tedesca come un modo per lasciare nel loro brodo i bilanci statali ad alto deficit ma sostenere le imprese che fanno parte della supply chain tedesca.