I fenomeni di odio sono in allarmante crescita in Italia. E rischiano di minare la coesione sociale, la solidarietà e la fiducia. Uno strumento per contrastarli è la partecipazione ad attività culturali. Lo dimostrano i risultati di uno studio.
Odio e cultura
I fenomeni di odio sono all’ordine del giorno in Italia e nel resto d’Europa. I discorsi di incitamento all’odio, le aggressioni e gli atti vandalici con movente xenofobo, razzista e omo/transfobico non hanno avuto battute di arresto nemmeno durante la pandemia causata dal Covid-19.
Questi fenomeni hanno un impatto devastante sulle vittime e sulla società. Le persone colpite sperimentano vulnerabilità e ansia, con conseguenze anche sulla loro vita sociale e lavorativa. I fenomeni di odio danneggiano anche le persone vicine alle vittime, poiché il senso di paura si riversa sull’intero gruppo. L’odio mina la coesione sociale, smorza la collaborazione, la solidarietà e la fiducia.
La proliferazione dell’odio ha stimolato un crescente impegno istituzionale di contrasto che si articola in azioni di deterrenza, sostegno alle vittime e analisi dei fattori di rischio e dei fattori protettivi legati all’insorgenza del fenomeno. Nell’ambito dei fattori di rischio e di quelli protettivi, sta crescendo l’interesse per il ruolo del contesto socioeconomico in cui si muovono gli odiatori. Dati recenti mostrano che disoccupazione, inuguaglianza e condizioni climatiche rappresentano fattori di rischio.
Tra i fattori protettivi in grado di contrastare l’odio, la partecipazione ad attività culturali può giocare un ruolo rilevante. L’odio ha una radice culturale, poiché si basa sui pregiudizi e gli stereotipi culturali di una comunità. Studi recenti nel campo delle scienze del comportamento mostrano che l’esposizione a nuovi stimoli culturali modifica quelli esistenti favorendone il superamento. Questi dati supportano la teoria del “contatto indiretto”, secondo cui la partecipazione ad attività culturali facilita lo sviluppo di nuove prospettive perché i fruitori si identificano con i personaggi e le tematiche proposte uscendo dal perimetro delle norme sociali a cui sono abituati.
In uno studio recente abbiamo verificato se la riduzione dell’odio prodotta dalla partecipazione ad attività culturali si riscontra anche uscendo da un contesto sperimentale, che considera un numero ristretto di persone, per allargare l’analisi a un intero paese.
L’analisi
Il legame tra consumi culturali e odio in Italia è rilevante per due ragioni. La prima riguarda i fenomeni di odio, che in Italia sono in allarmante crescita da diversi anni (La Repubblica, 2020; Osce-Odihr, 2020). La seconda riguarda il sempre maggiore numero di italiani che non partecipano ad alcuna attività culturale (Istat, 2020).
La nostra analisi quantifica la relazione tra incidenza dei fenomeni di odio e partecipazione ad attività culturali usando un nuovo database, che contiene l’incidenza dei fenomeni di odio e i consumi culturali per abitante georeferenziati sulle province italiane tra 2009 e 2018. I dati sui fenomeni di odio provengono dal database dell’associazione Lunaria, utilizzato da istituzioni internazionali, come l’Osce e la Commissione europea, che vi fanno spesso riferimento nel monitoraggio del fenomeno in Italia. Per la partecipazione ad attività culturali abbiamo utilizzato i dati provinciali dell’Osservatorio dello spettacolo della Siae che misurano il pubblico degli eventi culturali pubblici e privati. Questi dati rilevano l’affluenza a concerti, cinema, teatro, opera, commedie musicali, danza, mostre, attrazioni dello spettacolo viaggiante, sia gratuita che a pagamento. In alcuni territori, le iniziative culturali vedono una maggiore partecipazione di turisti relativamente a quella dei residenti, che sono il focus della nostra analisi. È stato quindi necessario calibrare i dati dell’Osservatorio Siae per l’attrattività turistica della rispettiva provincia, per depurarli dall’apporto dei turisti.
La figura 1 mostra la relazione tra fenomeni di odio e partecipazione ad attività culturali nelle province italiane tra 2009 e 2018.
Figura 1 – Correlazione tra incidenza all’odio e partecipazione alle attività culturali (2009-2018)

La figura 1 mostra che incidenza dell’odio e partecipazione alle attività culturali presentano marcate differenze tra le province e che la relazione tra le due variabili è negativa. Quindi, le province con maggiore partecipazione ad attività culturali hanno minore incidenza di odio. Questo elemento è confermato anche da un modello di regressione, in cui abbiamo verificato l’eventuale effetto di altri fattori di contesto che potrebbero avere un ruolo, come livello di capitale umano, capitale sociale, popolazione straniera, criminalità, rifugiati, disoccupazione.
La relazione che abbiamo individuato, ossia che maggiore partecipazione culturale è associata a minore incidenza di odio, non dice ancora nulla su un eventuale rapporto di causalità. Per avere una misura di questo secondo aspetto, abbiamo applicato un modello di regressione con variabile strumentale, che stima l’influenza statistica della partecipazione ad attività culturale sull’incidenza dell’odio riducendo la possibilità che il risultato che si osserva sia dovuto a spiegazioni alternative. La nostra variabile strumentale è costruita utilizzando la partecipazione storica alle attività culturali nelle province italiane. Partendo dai dati provinciali sulla partecipazione ad attività culturali nel 1955, abbiamo costruito un indicatore sintetico della partecipazione ad attività culturali. Questo indicatore, di tipo Bartik, fa crescere annualmente la partecipazione provinciale ad attività culturali del 1955 con il tasso di crescita nazionale. In questo modo, possiamo isolare alcuni elementi che potrebbero altrimenti influenzare i nostri risultati, come lo spostamento delle persone nel territorio e la cosiddetta causalità inversa, per la quale è l’incidenza dell’odio a influenzare la partecipazione alle attività culturali.
La seconda stima conferma che la maggiore partecipazione ad attività culturali determina statisticamente una riduzione dei fenomeni di odio. A questo risultato, si aggiunge che nel periodo considerato una parte significativa delle attività culturali in Italia si è occupata di tematiche di inclusione e tolleranza, producendo contenuti culturali che favoriscono il superamento dei pregiudizi secondo la teoria del “contatto indiretto”. Quindi il nostro studio conferma su una scala-paese i dati precedentemente prodotti in letteratura da esperimenti su gruppi di persone.
Questi risultati sottolineano l’importanza del favorire l’accesso alla cultura nei territori ai fini di favorire comunità più inclusive e aggiungono un ulteriore valore alle politiche culturali come strumento di contrasto all’odio.
Lavoce è di tutti: sostienila!
Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

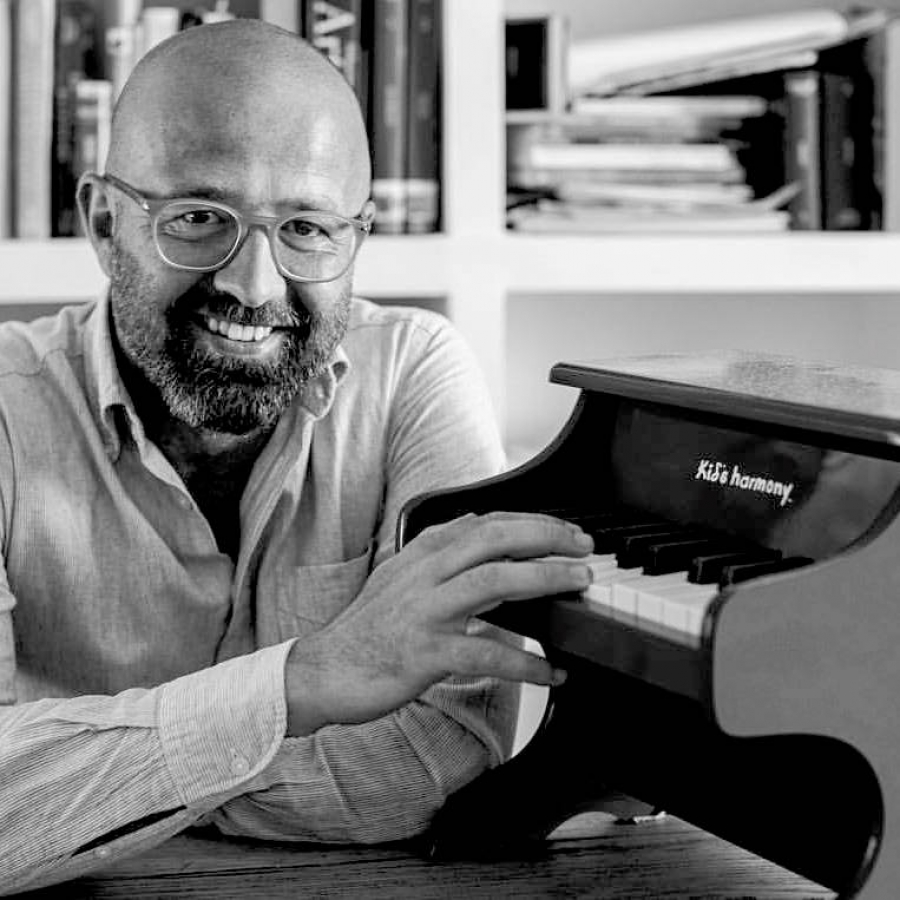 Professore Associato presso GSSI - Gran Sasso Science Institute. Ricercatore esperto con focus sull'economia culturale. Forte formazione professionale specializzata in sviluppo sostenibile, politica culturale, conferenze, patrimonio culturale, economia creativa e studi urbani.
Professore Associato presso GSSI - Gran Sasso Science Institute. Ricercatore esperto con focus sull'economia culturale. Forte formazione professionale specializzata in sviluppo sostenibile, politica culturale, conferenze, patrimonio culturale, economia creativa e studi urbani. Assistan Professor presso il Gran Sasso Science Institute e Visiting Research Fellow presso la London School of Economics, Dipartimento di Geografia e Ambiente. I sui interessi di ricerca si collocano all'intersezione tra economia, geografia economica e violazioni dei diritti umani. È autrice di ricerche sull’odio online, violenza di genere e femminicidi, pubblicate in riviste di elevato profilo scientifico
La sua tesi di dottorato "Essays on the economic geography of oppressive violent deviant behaviours" ha vinto il premio per la migliore tesi del 2020 della Regional Science Association International. Su twitter
Assistan Professor presso il Gran Sasso Science Institute e Visiting Research Fellow presso la London School of Economics, Dipartimento di Geografia e Ambiente. I sui interessi di ricerca si collocano all'intersezione tra economia, geografia economica e violazioni dei diritti umani. È autrice di ricerche sull’odio online, violenza di genere e femminicidi, pubblicate in riviste di elevato profilo scientifico
La sua tesi di dottorato "Essays on the economic geography of oppressive violent deviant behaviours" ha vinto il premio per la migliore tesi del 2020 della Regional Science Association International. Su twitter  Professore Ordinario di Economia Applicata, direttore delle Scienze Sociali e Prorettore alla ricerca presso il Gran Sasso Science Institute, L’Aquila, Italia., È attualmente Vice Presidente della Società Italiana degli Economisti e membro dei consigli direttivi dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRe) e della Western Regional Science Association (WRSA) negli Stati Uniti. I suoi interessi di ricerca riguardano l'economia regionale e urbana, la demografia, l'economia del lavoro e l'economia dell'istruzione. Le sue pubblicazioni coprono un'ampia gamma di argomenti, tra cui migrazione, capitale umano, mercati del lavoro, creatività, innovazione e crescita locale. È coautrice di oltre 80 pubblicazioni accademiche. I suoi articoli sono apparsi su riviste come Oxford Economics Papers, Cambridge Journal of Economics, Feminist Economics, Regional Studies, Papers in Regional Science, Journal of Regional Science e The Journal of Economic Geography. Nel 2021 è stata nominata Fellow della Regional Science Association International nel 2020 ha ricevuto l’ERSA Prize dalla European Regional Science Association.
Professore Ordinario di Economia Applicata, direttore delle Scienze Sociali e Prorettore alla ricerca presso il Gran Sasso Science Institute, L’Aquila, Italia., È attualmente Vice Presidente della Società Italiana degli Economisti e membro dei consigli direttivi dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRe) e della Western Regional Science Association (WRSA) negli Stati Uniti. I suoi interessi di ricerca riguardano l'economia regionale e urbana, la demografia, l'economia del lavoro e l'economia dell'istruzione. Le sue pubblicazioni coprono un'ampia gamma di argomenti, tra cui migrazione, capitale umano, mercati del lavoro, creatività, innovazione e crescita locale. È coautrice di oltre 80 pubblicazioni accademiche. I suoi articoli sono apparsi su riviste come Oxford Economics Papers, Cambridge Journal of Economics, Feminist Economics, Regional Studies, Papers in Regional Science, Journal of Regional Science e The Journal of Economic Geography. Nel 2021 è stata nominata Fellow della Regional Science Association International nel 2020 ha ricevuto l’ERSA Prize dalla European Regional Science Association.
Savino
L’argine all’odio e alla stupidità è, oggi, dare una disciplina ai social network, luoghi di perdizione e non di discussione.
Luca Neri
Il problema principale di questo articolo è la questione dell’identificazione dell’effetto causale. Non è affatto scontato che lo strumento utilizzato sia in grado di eliminare il dubbio di reverse causality perchè la relazione tra “crimini d’odio” e partecipazione ad eventi culturali può avere ragioni storiche di lungo corso, oppure potrebbero entrambe correlare con la distribuzione della coesione sociale di cui potrebbero essere entrambe effetto e non causa.
B&B
L’argine all’odio è la cultura del non odio, che non appartiene alla politica.
bob
la cultura e il sapere ha sempre terrorizzato Il Potere sia laico che soprattutto Religioso. Colpevolizzare gli strumenti a disposizione è fuorviante sarebbe da valutare chi e come li usa.
Certo la facilità di ” accesso” che permette la rete complica le cose ….come sosteneva Umberto Eco
” Internet? Ha dato diritto di parola agli imbecilli: prima parlavano solo al bar e subito venivano messi a tacere””