La giustizia, applicando la legge vigente, respinge la rivendicazione dei fattorini di Foodora di essere qualificati come lavoratori subordinati. Così la tutela essenziale di questi lavoratori rimane senza risposta. Eppure esperienze di altri paesi mostrano la possibilità di creare un sistema di protezione.
Autore: Pietro Ichino Pagina 5 di 8
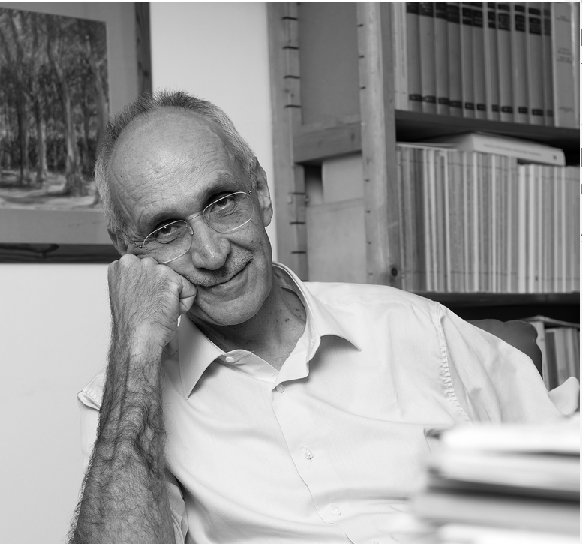 Nato a Milano nel 1949, è stato dirigente sindacale della Fiom-Cgil dal 1969 al 1972; dopo il servizio militare, dal 1973 al 1979 è stato responsabile del Coordinamento servizi legali della Camera del Lavoro di Milano. Dal 1970 è iscritto all’Albo dei Giornalisti e dal 1975 a quello degli Avvocati. Nell’ottava legislatura (1979-1983) è stato membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Partito comunista italiano. Ricercatore dal 1983 nell’Università statale di Milano, dal 1986 al 1991 è stato professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università di Cagliari; dal 1991 è professore ordinario della stessa materia nell’Università statale di Milano. Nel 1985 ha assunto l’incarico di coordinatore della redazione della “Rivista italiana di diritto del lavoro” (diretta dal prof. Giuseppe Pera), della quale è stato vicedirettore dal 1991 e direttore responsabile dal 2002 al 2008, quando è stato eletto al Senato. È stato senatore dal 2008 al 2018. Dal 1997 è editorialista del Corriere della Sera. Dall’aprile 1998 al marzo 1999 ha collaborato anche con l’Unità. Quasi tutte le sue pubblicazioni sono disponibili nell’Archivio degli scritti di Pietro Ichino, agevolmente raggiungibile dal suo sito: www.pietroichino.it.
Nato a Milano nel 1949, è stato dirigente sindacale della Fiom-Cgil dal 1969 al 1972; dopo il servizio militare, dal 1973 al 1979 è stato responsabile del Coordinamento servizi legali della Camera del Lavoro di Milano. Dal 1970 è iscritto all’Albo dei Giornalisti e dal 1975 a quello degli Avvocati. Nell’ottava legislatura (1979-1983) è stato membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Partito comunista italiano. Ricercatore dal 1983 nell’Università statale di Milano, dal 1986 al 1991 è stato professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università di Cagliari; dal 1991 è professore ordinario della stessa materia nell’Università statale di Milano. Nel 1985 ha assunto l’incarico di coordinatore della redazione della “Rivista italiana di diritto del lavoro” (diretta dal prof. Giuseppe Pera), della quale è stato vicedirettore dal 1991 e direttore responsabile dal 2002 al 2008, quando è stato eletto al Senato. È stato senatore dal 2008 al 2018. Dal 1997 è editorialista del Corriere della Sera. Dall’aprile 1998 al marzo 1999 ha collaborato anche con l’Unità. Quasi tutte le sue pubblicazioni sono disponibili nell’Archivio degli scritti di Pietro Ichino, agevolmente raggiungibile dal suo sito: www.pietroichino.it.
Se con il Patto per la fabbrica Cgil, Cisl, Uil e Confindustria volevano mostrare la capacità di autogoverno del sistema delle relazioni industriali, non ci sono riuscite. L’accordo non dice nulla sui problemi più importanti e le possibili soluzioni.
Il braccialetto brevettato da Amazon di per sé non comporta alcuna forma di controllo a distanza del lavoratore. Ciò che va verificato in concreto e rivendicato è la compatibilità con il benessere psico-fisico di chi lo usa. E la spartizione equa del guadagno di produttività.
La nuova frontiera del diritto del lavoro non è in un radicale ridisegno della disciplina inderogabile del rapporto di lavoro tradizionale. Ma è nella costruzione di un diritto soggettivo al sostegno efficace nella transizione da vecchio a nuovo lavoro.
Il nuovo lavoro occasionale reintroduce una normativa relativamente complessa, che richiede un consulente per essere compresa e applicata. Così tornerà probabilmente a essere relegato al di sotto dello 0,01 del totale del lavoro regolare svolto in Italia.
Prima di far scomparire i voucher, si sarebbe dovuto stabilire se hanno o meno prodotto effetti positivi. Ma la Cgil ne fa una questione di principio, considerando sbagliata gran parte della legislazione per la semplificazione della disciplina del rapporto di lavoro dipendente.
I referendum proposti dalla Cgil su licenziamenti, voucher e appalti devono ancora sottostare all’esame della Corte costituzionale. Ma si può iniziare a ragionare sul loro contenuto e sugli effetti che una ipotetica vittoria dei “sì” provocherebbe sul nostro mercato del lavoro.
L’autonomia del sistema di relazioni industriali è un principio nobile, ma rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e contrattazione collettiva aziendale sono già regolate da almeno due norme. Si tratta di una disciplina insufficiente, che rende necessario un nuovo intervento legislativo.
L’accordo firmato martedì dalle tre confederazioni sindacali maggiori con Confindustria è di grande importanza. Può forse concludere la lunghissima fase del cosiddetto diritto sindacale transitorio, aperta nel 1944. Sicuramente mette fine a un decennio di relazioni sindacali rissose e poco concludenti. Le divergenze tra la Cgil e le altre due confederazione non sono superate, ma l’accordo detta le regole di democrazia sindacale che consentiranno di dirimere i contrasti.
Due anni fa, nel novembre 2008, il ministro Alfano, al Congresso nazionale forense di Bologna, fece agli avvocati un discorso che suonava sostanzialmente così: “se mi portate un disegno di riforma sul quale concordino tutte le componenti e le voci dellavvocatura, io mi impegno a farlo passare in Parlamento”. Questo discorso avrebbe avuto un senso nel contesto dell’ordinamento corporativo. Dopo la sua abrogazione, la disciplina della professione forense deve intendersi come posta esclusivamente nellinteresse dellamministrazione della giustizia e della collettività degli utenti del servizio. Sulle linee e sui contenuti della riforma, dunque, non poteva certo bastare un accordo limitato alle componenti interne dellavvocatura.
LA BOTTEGA DELL’AVVOCATO
Questo è sicuramente uno dei motivi per cui il disegno di legge, in un primo tempo affrettatamente licenziato dalla Commissione Giustizia del Senato, ha visto poi il proprio iter procedere con grande difficoltà, incagliandosi più volte, avversato fortemente dallantitrust, dalle associazioni imprenditoriali, da quelle dei consumatori e persino da quelle dei giovani avvocati. A tutte queste voci il ministro ha preferito non dare ascolto, mantenendo il proprio appoggio al progetto approvato dal Consiglio Nazionale Forense, che segna un netto ritorno all’indietro rispetto al decreto Bersani del 2006.
Contro un principio preciso dell’ordinamento europeo e del nostro ordinamento nazionale, il progetto si propone di reintrodurre l’inderogabilità delle tariffe minime (mercoledì scorso, al termine di un dibattito lungo e molto teso, il Senato ha approvato in prima lettura questa norma, che ribalta la regola posta dal decreto Bersani nel 2006); di reintrodurre il divieto della pubblicità commerciale per gli studi professionali; di reintrodurre la necessità (da tempo superata) dell’iscrizione all’albo anche per poter svolgere attività di consulenza stragiudiziale; di ribadire e rafforzare il divieto di costituzione degli studi legali in forma di società per azioni (consentita invece, sia pure con qualche opportuna limitazione, nella maggior parte dei Paesi occidentali); di rafforzare le barriere che devono essere superate dai giovani per accedere alla libera professione; di sfoltire drasticamente gli albi escludendone tutti coloro che esercitano la professione secondo un modello diverso da quello tradizionale (a tempo pieno, in modo esclusivo e continuativo per tutta la vita); di tornare ad attribuire esplicitamente all’Ordine una funzione di sostanziale rappresentanza degli interessi economici e professionali della categoria. Il modello di studio legale a cui si ispira questo progetto di riforma è quello tradizionale dello studio-bottega artigiana, nel quale il professionista opera a tempo pieno in modo continuativo ed esclusivo, in collaborazione con un numero limitato di colleghi e di collaboratori: ogni altra forma di esercizio della professione, secondo questo disegno, deve considerarsi sostanzialmente vietata.
DA CERNOBBIO AL SENATO
Soltanto poche settimane fa il ministro Tremonti proponeva di sancire esplicitamente nella Costituzione il principio per cui “tutto ciò che non è vietato è permesso”. In questo disegno di legge si dice sostanzialmente il contrario: “tutto ciò che non corrisponde al modello tradizionale di esercizio della professione forense è vietato”.
Deve aver provato qualche imbarazzo per questo progetto anche lo stesso ministro della Giustizia Alfano quando, meno di due mesi fa, al seminario Ambrosetti di Cernobbio, di fronte ai protagonisti dell’economia e della finanza globale e alla stampa internazionale, lo ha in parte sconfessato dichiarando pubblicamente che non era intenzione del Governo reintrodurre l’inderogabilità delle tariffe minime. Ma mercoledì scorso in Senato il Governo è tornato a difendere il progetto nella sua interezza, comprese le tariffe minime inderogabili e tutti gli altri divieti mirati a perpetuare, rendendolo esclusivo, il modello tradizionale dello studio legale-bottega artigiana che piace tanto al Consiglio Nazionale Forense
L’imposizione di quel modello tradizionale come unico modo possibile di esercizio della professione da parte degli avvocati italiani, oltretutto, impedisce loro di competere ad armi pari con i colleghi stranieri, all’estero e persino sullo stesso nostro territorio nazionale. Ve lo immaginate uno studio legale italiano che prova a offrire i propri servizi sulla piazza di Londra o di Chicago dovendo rispettare questa legge, quindi non potendo raccogliere nel mercato azionario i capitali per gli investimenti necessari, non potendo di fatto promuovere una class action perché il divieto del patto di quota-lite non lo consente, non potendo neppure informare i potenziali clienti della propria esistenza per via del divieto della pubblicità? Gli studi di Londra e di Chicago, però, sono già venuti da noi, stanno già incominciando a prendersi il meglio del nostro mercato dei servizi legali, senza certo render conto al nostro Consiglio nazionale forense sul come hanno reperito i capitali necessari, quali tariffe applicano ai loro clienti, con quale tipo di contratto ingaggiano i collaboratori e così via.
La verità è che con questo disegno di legge si sta facendo un’operazione regressiva, che non va nell’interesse del Paese, ma non va neppure nell’interesse particolare della stessa avvocatura italiana.
