La legge di bilancio prevede una compartecipazione a favore dello stato del gettito dell’imposta di soggiorno. Così parte degli introiti raccolti tassando a livello locale i turisti servirà a coprire fondi nazionali per l’assistenza a disabili e minori.
La tassa di soggiorno nella legge di bilancio
Il disegno di legge di bilancio introduce una serie di interventi in materia di imposta di soggiorno (art. 121) che suscitano inquietudine tra i comuni.
Il primo intervento è la proroga per il 2026 delle misure introdotte per l’anno giubilare 2025, che permettevano ai comuni di aumentare le aliquote dell’imposta fino a 2 euro per notte di soggiorno, come compensazione dei costi aggiuntivi nella gestione dei flussi turistici previsti per quest’anno speciale.
Il secondo riguarda l’attivazione di una compartecipazione a favore dello stato sull’aumento di gettito dell’imposta: il 30 per cento del “maggior gettito derivante dall’incremento dell’imposta di soggiorno incassato nel 2026” viene destinato al bilancio statale per contribuire a due fondi assistenziali nazionali. Uno è il fondo per l’inclusione delle persone con disabilità con finalità di potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni in stato di bisogno (legge 213/2023, art. 1, c. 213, lettera a), di seguito “fondo disabilità”), l’altro è il fondo per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla famiglia con provvedimento dell’autorità giudiziaria (legge 207/2024, art. 1, c. 759, di seguito fondo per l’assistenza ai minori).
Le modalità per l’individuazione del maggior gettito, delle riduzioni dei trasferimenti statali per i comuni interessati con cui si realizzerà operativamente la compartecipazione, nonché dei criteri per il riparto e la destinazione dei fondi saranno stabiliti da un regolamento da emanare, d’intesa con la Conferenza stato-città e autonomie locali, entro il prossimo aprile.
Un’imposta dinamica
L’imposta di soggiorno (qui) è un tributo proprio dei comuni (decreto legislativo 23/2011, art. 4), ma con un gettito vincolato al finanziamento di specifici interventi locali in materia di turismo, di gestione dei beni culturali e ambientali, nonché della spesa relativa ai servizi pubblici locali, incluso raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si configura pertanto come un’imposta correttiva (si colpiscono i turisti per i maggiori costi generati) e, contestualmente, come un’imposta di scopo (sono specificati gli impieghi del gettito). L’assenza di una procedura contabile analitica obbligatoria sulle destinazioni del gettito da parte dei singoli comuni indebolisce tuttavia l’effettività del vincolo.
Non tutti i comuni hanno facoltà di introdurre l’imposta di soggiorno. Sono eleggibili solo quelli a vocazione turistica o le città d’arte, inclusi in appositi elenchi regionali, nonché i capoluoghi di provincia, le unioni di comuni e gli enti amministrativi delle isole minori. Anche se eleggibili, i comuni hanno comunque piena discrezionalità nel definire tanto il margine estensivo del tributo (se introdurlo o meno), quanto quello intensivo (il livello delle aliquote, qui denominate in euro per pernottamento). La legge non prevede un’aliquota minima (standard) che deve essere applicata da tutti i comuni. L’unico vincolo è di non superare i 7 euro per notte, che diventano 12 euro per i comuni che hanno un flusso turistico venti volte superiore alla popolazione residente. Attualmente, su circa 8mila comuni, 5.700 sono eleggibili ma solo 1.382 hanno effettivamente attivato l’imposta di soggiorno (circa il 13 per cento dei comuni totali e il 24 per cento degli eleggibili).
Rispetto ad altri tributi comunali che hanno gettiti molto stabili nel tempo, come l’Imu, questa è un’imposta dinamica, con un gettito in continua crescita, per di più prelevato da contribuenti non residenti nel territorio comunale, spesso anche stranieri. Nel 2024 il gettito ha raggiunto 1.024 milioni di euro (+29 per cento rispetto al 2023) e si prevede un ulteriore incremento del 16 per cento per quest’anno, che porterà il totale, secondo le stime, a 1.186 milioni. Gli incrementi di gettito sono principalmente attribuibili a un aumento della domanda di flussi turistici, ma anche alle scelte discrezionali dei comuni di attivare o incrementare il prelievo.
Di recente sono state avanzate varie proposte di razionalizzazione. Nel settembre del 2024 era circolata una bozza di legge che proponeva due interventi significativi: da un lato, l’abolizione degli elenchi regionali dei comuni a cui è riconosciuta la potestà di introdurre l’imposta, con l’obiettivo di renderla attivabile da tutti gli enti; dall’altro, la ridefinizione della base imponibile in termini monetari (il prezzo della stanza) in sostituzione dell’indicatore sintetico della qualità della struttura ricettiva oggi adottato (le “stelle” per gli alberghi, i “soli” per gli agriturismi, e così via). Nonostante il consenso raggiunto per l’abolizione degli elenchi, della revisione dell’imposta non se ne è fatto nulla.
Ombre lunghe sul prelievo
L’introduzione nell’imposta di soggiorno della compartecipazione a favore dello stato (una “compartecipazione verso l’alto”) per il finanziamento dei due fondi in materia assistenziale contenuta dal disegno della legge di bilancio sembra in contrasto sia con la struttura dell’imposta sia con le proposte di riforma.
In primo luogo, i due fondi si riferiscono a provvedimenti a tutela di diritti civili e sociali, come appunto il fondo disabilità (260 milioni di euro previsti nel 2025 per assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità) e quello per l’assistenza ai minori (100 milioni di euro annui per il periodo 2025-2027, ma con un incremento di 150 milioni previsto nel disegno di legge di bilancio). Dovrebbero rientrare integralmente nelle competenze del governo centrale e quindi il loro finanziamento dovrebbe essere affidato alla fiscalità generale, anche se le misure effettive a favore dei cittadini in condizioni di bisogno sono fornite dai comuni.
Peraltro, il disegno di legge di bilancio stabilisce un livello essenziale delle prestazioni (Lep) da garantire su tutto il territorio nazionale, nell’ambito dell’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli studenti con disabilità, in termini di ore di assistenza da garantire agli studenti in condizione di bisogno. Al finanziamento delle prestazioni determinate dal Lep concorrerà la compartecipazione sull’imposta di soggiorno, apparentemente in sostituzione di risorse statali, dato che il disegno di legge di bilancio non prevede alcun incremento negli stanziamenti complessivi a favore del fondo. Perché si ricorra all’imposta di soggiorno per finanziare un intervento di carattere nazionale di questo genere, su cui rilevano diritti civili e sociali come confermato dalla fissazione del Lep, è difficile da comprendere.
In secondo luogo, appare improprio ricorre a un’imposta non generale, come è appunto quella di soggiorno, che può essere attivata solo da un sottoinsieme limitato di comuni, per finanziare misure assistenziali di carattere generale, come quelle effettuate da tutti i comuni a tutela dei disabili e dei minori. In più, in assenza di un’aliquota base dell’imposta fissata dalla normativa nazionale, obbligatoria per tutti i comuni, non è in questa fase definibile una capacità fiscale standard per ogni ente. La compartecipazione statale sarebbe dunque applicata all’intero gettito incrementale, che comprende anche la quota relativa allo “sforzo fiscale” derivante dalle scelte discrezionali dell’ente. Ciò sembra in contrasto con i principi base del federalismo fiscale. Per rendere tecnicamente possibile una compartecipazione statale al gettito dell’imposta di soggiorno, sarebbe quantomeno necessario rendere generale il prelievo comunale — cioè, attivabile da tutti gli enti — e fissare un’aliquota base da applicare obbligatoriamente, a cui associare una capacità fiscale standard per applicare la compartecipazione statale.
Come si calcola la compartecipazione?
Rimane poi aperta la questione relativa alle modalità operative con cui sarà determinata la compartecipazione, dalla cui definizione dipenderà l’ammontare effettivo delle risorse attribuite allo stato (la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio non riporta alcuna stima ufficiale). Come verrà calcolato il “maggior gettito” del 2026? Rispetto ai gettiti del 2024 (quelli prima del possibile incremento delle aliquote concesso per l’anno giubilare 2025) o rispetto ai gettiti del 2025? Si considererà, per semplicità amministrativa, l’intero incremento realizzato, qualsiasi sia la sua determinante – incremento della domanda di ospitalità da parte dei turisti, aumento delle aliquote, attivazione dell’imposta da parte di nuovi comuni? Oppure si cercherà di individuare la componente riconducibile soltanto alla crescita del numero dei pernottamenti?
L’impressione generale è che l’intervento risponda soltanto all’esigenza di reperire risorse finanziarie. Ma il governo deve davvero ricorrere al gettito raccolto tassando a livello locale i turisti per coprire fondi statali rilevanti per i servizi sociali a livello nazionale, come l’assistenza ai disabili e ai minori?
Lavoce è di tutti: sostienila!
Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!


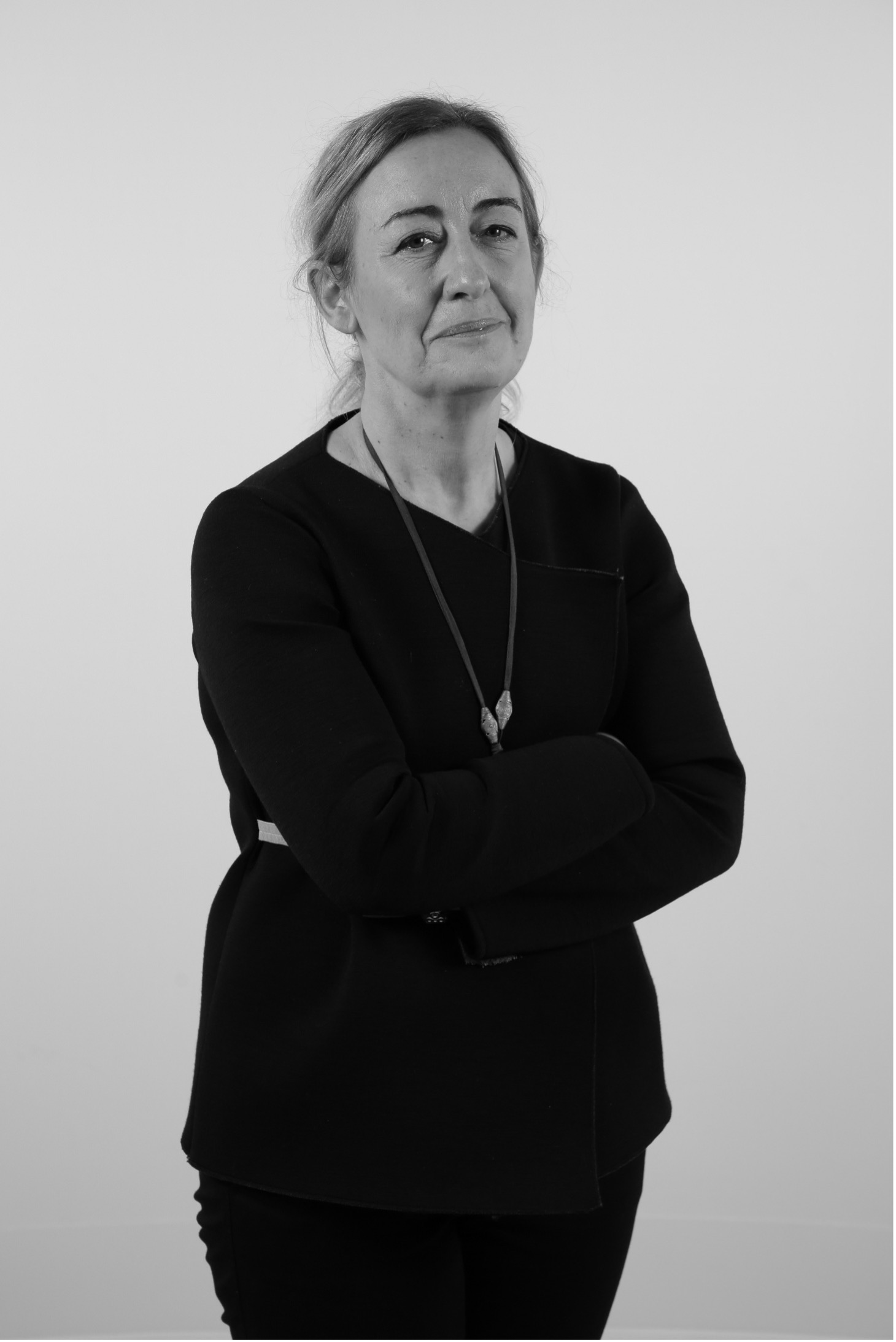 Emanuela Randon è Professoressa Associata di Scienza delle Finanze nel Dipartimento di Scienze Economiche presso l’Università di Bologna. Le sue tematiche di ricerca comprendono l’analisi positiva e normativa dell’esternalità, la disuguaglianza e le politiche redistributive di tassazione, con applicazioni al gioco d’azzardo e all’imposta di soggiorno. Recentemente ha valutato l’impatto dell’incertezza sulle politiche pubbliche di contrasto alla pandemia.
Ha conseguito un Master in Economics (Università Bocconi), un Dottorato di Ricerca in Economia Politica (Università Bocconi- Università Cattolica - Università degli Studi di Milano) e un Phd in Economics presso University of York. Ha trascorso soggiorni di visiting presso UCSD - University of California San Diego (USA).
È attualmente Vicedirettrice del CAST (Centre for Advanced Studies in Tourism) e Presidente del Comitato Scientifico della Biblioteca Centrale del Campus di Rimini- Università di Bologna. È stata membro dell’Advisory Board dell’Osservatorio Mercati Regolati – Progetto Gioco Legale, costituito da LUISS Business School e Ipsos (2021-2024) e dell’Osservatorio “Gioco e Giovani” costituito da Nomisma e Università di Bologna.
Ha conseguito il Diploma in Pianoforte presso il Conservatorio G. Nicolini di Piacenza.
Emanuela Randon è Professoressa Associata di Scienza delle Finanze nel Dipartimento di Scienze Economiche presso l’Università di Bologna. Le sue tematiche di ricerca comprendono l’analisi positiva e normativa dell’esternalità, la disuguaglianza e le politiche redistributive di tassazione, con applicazioni al gioco d’azzardo e all’imposta di soggiorno. Recentemente ha valutato l’impatto dell’incertezza sulle politiche pubbliche di contrasto alla pandemia.
Ha conseguito un Master in Economics (Università Bocconi), un Dottorato di Ricerca in Economia Politica (Università Bocconi- Università Cattolica - Università degli Studi di Milano) e un Phd in Economics presso University of York. Ha trascorso soggiorni di visiting presso UCSD - University of California San Diego (USA).
È attualmente Vicedirettrice del CAST (Centre for Advanced Studies in Tourism) e Presidente del Comitato Scientifico della Biblioteca Centrale del Campus di Rimini- Università di Bologna. È stata membro dell’Advisory Board dell’Osservatorio Mercati Regolati – Progetto Gioco Legale, costituito da LUISS Business School e Ipsos (2021-2024) e dell’Osservatorio “Gioco e Giovani” costituito da Nomisma e Università di Bologna.
Ha conseguito il Diploma in Pianoforte presso il Conservatorio G. Nicolini di Piacenza.
 Professore ordinario di Scienza delle finanze nell'Università di Bologna. Attualmente è componente del -Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa pubblica istituito presso il MEF. Durante il 2022 è stato presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard presso il MEF e tra il 2014 e il 2022 componente del Consiglio direttivo dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Nel passato ho fatto parte della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale e della Commissione tecnica per la finanza pubblica presso il MEF.
Professore ordinario di Scienza delle finanze nell'Università di Bologna. Attualmente è componente del -Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa pubblica istituito presso il MEF. Durante il 2022 è stato presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard presso il MEF e tra il 2014 e il 2022 componente del Consiglio direttivo dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Nel passato ho fatto parte della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale e della Commissione tecnica per la finanza pubblica presso il MEF.
ALESSANDRO PETRETTO
Alberto, stavo per scrivere io su questa barbarie (ennesima) dí smantellamento del federalismo fiscale. Comunque ottimo
bob
anno infausto per questo Paese? 1970.