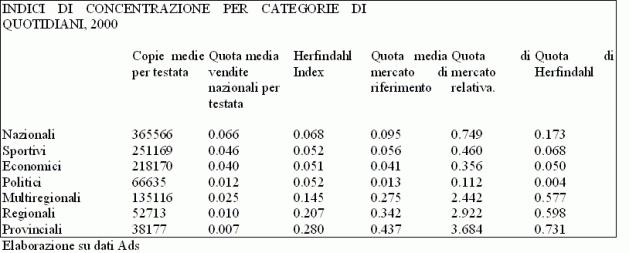Allinizio di luglio, quando ci preparavamo a festeggiare il secondo compleanno de lavoce, ci siamo ritrovati orfani di Tremonti. Raramente una persona ha rappresentato la politica economica di un intero governo, come è avvenuto negli anni in cui Giulio Tremonti è stato il Ministro delleconomia. Come regalo di Natale per i nostri lettori, riproduciamo qui gli articoli in cui abbiamo discusso la sua eredità. Il controllo pubblico dell’economia è rimasto invariato, con il paradosso di imprese in mano pubblica che si comportano come private. Sul lato delle entrate, condono e scudo fiscale hanno tramandato al successore un calo strutturale del gettito. Sul lato della spesa, non c’e’ stato alcuno sforzo di ridurla, ma neanche una completa perdita di controllo come spesso paventato. Gli artifici sul debito hanno ridotto la trasparenza dei nostri conti pubblici.
La politica di bilancio perseguita in Italia negli ultimi anni si presta a una lettura diversa da quella che ne dà Roberto Perotti nel suo articolo su lavoce.info “La macroeconomia di Tremonti”. La mia analisi si differenzia soprattutto per quanto riguarda gli anni Novanta. (1) La pressione fiscale Nel 1992, dopo oltre dieci anni di disordine finanziario, l’Italia era stata colpita dalla più grave crisi valutaria e finanziaria dopo il 1949: i rischi di insolvenza erano reali e il governo Amato presentò una manovra correttiva che diede il via al processo di risanamento del bilancio che fu poi proseguito dal governo Ciampi nel 1993. A fine 1996 la situazione risultava migliorata, grazie alla manovra correttiva subito operata dal governo Prodi nel giugno. Tuttavia (vedi Tavola 1), il disavanzo del settore pubblico continuava a superare il 7 per cento e il surplus primario (4,4 per cento) risultava ancora insufficiente rispetto a quanto richiesto dal processo di convergenza; in compenso continuava una lenta discesa del rapporto debito Pil. Ulteriori informazioni circa le caratteristiche strutturali del risanamento si possono ricavare dalle Tavole 2 e 3 relative alla struttura della spesa pubblica e alla pressione fiscale in Italia negli anni Novanta. Come si può vedere, con l’eccezione del 1992-3 (gli anni della prima grande manovra di risanamento) e del 1997, che presentano picchi nel prelievo tributario, la pressione fiscale si è successivamente stabilizzata ai livelli prevalenti negli anni precedenti, intorno al 42 per cento del Pil.Quindi a livelli coincidenti con la media europea, e inferiori a quelli di non pochi paesi, per esempio della Francia. Non è corretto affermare, come spesso si è fatto, che il risanamento italiano si è basato su un eccesso di tassazione che ha interferito negativamente con l’attività economica. La realtà invece mostra che per gran parte degli anni Settanta e Ottanta il settore pubblico italiano si era illuso di poter finanziare spese crescenti con imposte chiaramente insufficienti (e cioè in disavanzo), per cui fu necessario un recupero di entrate fortemente concentrato in pochi anni su cui ancora si polemizza, ma che comunque si era completato agli inizi degli anni Novanta (vedi Tavole 1 e 3). Il punto di dissenso Sulla entità e adeguatezza della pressione fiscale e della spesa pubblica in Italia il dibattito e le polemiche sono continuate per tutti gli anni Ottanta e continuano tuttora. In proposito il punto rilevante di dissenso (spesso implicito) è il seguente: può l’Italia, paese fragile, caratterizzato da piccole e micro imprese, da una classe imprenditoriale provinciale, dall’assenza di una classe di manager professionali, da un capitalismo familiare e non di mercato, da tensioni sociali storiche, e classi dirigenti periodicamente inaffidabili, permettersi un sistema di welfare europeo, mercati concorrenziali, una corporate governance adeguata, un livello di pressione tributaria e di tax compliance soddisfacente? A ben vedere sono proprio le diverse risposte che si possono dare a queste domande che chiariscono e fanno comprendere le divisioni che si manifestarono allora e ancora si manifestano tra euroscettici e fautori della partecipazione all’Unione monetaria; e anche tra visione e programmi del centrosinistra e quelli della coalizione costruita da Silvio Berlusconi. Per fortuna, dal mio punto di vista, l’ingresso in Europa è avvenuto, e si tratta di un evento ragionevolmente irreversibile. La spesa pubblica Per quanto riguarda le spese, la Tavola 2 mostra che, rispetto al picco del 1993 (57,6 per cento del Pil), la spesa complessiva si è ridotta nel 2000 di 10,3 punti, liberando quindi massicciamente risorse per il settore privato. Tuttavia, ben 6,5 punti di tale riduzione derivano dalla diminuzione dei tassi di interesse, e solo 3,8 da una riduzione di spesa primaria, derivante soprattutto dalla riduzione del personale della pubblica amministrazione. Per quanto la spesa primaria italiana al netto degli interessi sia sempre stata, e sia ancora oggi, inferiore (di circa 3 punti di Pil) alla media europea, è certo che da questo punto di vista si sarebbe potuto fare di più: soprattutto per quanto riguarda la spesa pensionistica che è rimasta costante negli ultimi anni, ma che, nonostante tre o quattro successivi interventi di riforma, è ancora destinata a crescere nei prossimi decenni. In ogni caso, è chiaro qual’è stato l’equilibrio raggiunto dalla finanza pubblica italiana: una pressione fiscale pari alla media europea, e un livello di spesa primaria al netto degli interessi inferiore alla media europea e sufficiente a finanziare l’eccesso di spesa per interessi che, a (quasi) parità di tassi con gli altri paesi, risulta tuttavia doppia (almeno) di quella dei paesi che presentano uno stock di debito coerente col parametro di riferimento (60 per cento). Una fragilità intrinseca Queste considerazioni spiegano da un lato il malessere dei contribuenti che, a fronte di imposte elevate, non ottengono servizi di corrispondente valore. Dall’altro, quali siano le debolezze che permangono per il bilancio e la finanza pubblica italiana: è sufficiente infatti una crescita dei tassi di interesse di mercato per avere ripercussioni negative sul bilancio doppie rispetto agli altri paesi; la rigidità strutturale del bilancio è tale che basta un attimo di disattenzione, o un minimo di lassismo per ritrovarsi con deviazioni sostanziali dai criteri di convergenza. Ciò purtroppo è quanto si è verificato in Italia in questi tre anni di governo di una destra politica sostanzialmente euroscettica e con forti pulsioni populiste. E resta valido quanto già detto nel 2002: la intrinseca fragilità dell’equilibrio della finanza pubblica italiana dovrebbe suggerire la accelerazione dei processi di privatizzazione, il conseguimento di un surplus primario più elevato, il completamento della riforma previdenziale, e vincoli di spesa efficaci per le Regioni e gli enti locali.
* Questo intervento ripropone in sintesi la versione in italiano del testo preparato per il seminario “New Dimensions in Italian Public Policy” European Studies Centre, St Antony’s College, University of Oxford, 18 Oct.-29 Nov. 2002.
Sugli argomenti trattati si veda anche Chiorazzo V. e Spaventa L. Astuzia o virtù? Come accadde che l’Italia fu ammessa all’Unione monetaria, Donzelli (2000) e Onofri P. Un’economia sbloccata, Il Mulino (2001).





Possiamo fare il bilancio delle politiche industriali, privatizzazioni eccetera del “regno” di Giulio Tremonti? Per certi versi, ovviamente no perché il responsabile delle politiche industriali non è il ministro dell’Economia. Per altro, il ministro dell’Economia è colui che gestisce le partecipazioni in imprese ancora sotto il controllo pubblico e “ha il pallino in mano” per una serie di questioni di fondamentale importanza. Il sistema finanziario Sulla ristrutturazione del sistema finanziario, Tremonti ha perduto. Purtroppo. E mi riferisco non tanto alla riforma della protezione del risparmio, per la quale la partita è complessa, ma soprattutto al ruolo delle fondazioni bancarie, che restano al cuore del sistema finanziario italiano, soggetti né propriamente pubblici né veramente privati, residui delle peggiori abitudini della prima repubblica. (vedi Moise) Quanta voglia di Iri
Sulle imprese pubbliche e le privatizzazioni, non è facile dire se Tremonti abbia perso o abbia vinto: se solo se ne conoscesse il vero obiettivo
Capire quale fosse il fine di Tremonti sulla base del suo operare non è facile. Ingerenza e rilancio dell’impresa pubblica o orientamento genuino al privato? A parte questo, abbiamo visto solo cessioni di quote marginali (il 6,6 per cento di Enel un modo come altri di far cassa) o privatizzazioni “all’italiana”, ovvero azioni passate in mano alla Cassa depositi e prestiti, controllata a sua volta dalle fondazioni bancarie. E così resta purtroppo dominante la presenza pubblica in imprese che la propaganda da diversi anni vuole “privatizzate” (Eni, Enel) anche se i loro consigli di amministrazione sono di nomina pubblica. Alitalia Questa ex-impresa merita un capitolo a parte. Su questo, a quanto trapela, Tremonti ha perduto una battaglia. E ci dispiace. Alitalia è un’impresa tecnicamente fallita, e da tempo. (vedi Ponti 26-02-2004) I patetici tentativi di coprire la situazione con piani industriali che sono sempre quelli e sempre più improbabili e con interventi finanziari sempre più lontani dal cuore della questione sono stati approvati nonostante i richiami di Tremonti. Che forse a riguardo può essere accusato di essere stato troppo flessibile, ai limiti della complicità. Avere accettato l’idea del prestito ponte è stato un errore: un ponte ha senso quando sappiamo dove conduce. E un’impresa che perde un milione di euro al giorno non va da nessuna parte. Questo Tremonti lo sa bene: forse sa già che la Commissione boccerà il prestito? Credo comunque che avrebbe dovuto fare e dire di più, ma almeno i veri “cattivi” di questa vicenda senza speranza sono stati altri. Un bilancio? Tremonti non ha fatto peggio di altri, ma merita rispetto. Certo, non abbiamo visto nessuna delle rivoluzioni annunciate. E il problema è proprio che a riguardo è mancata una strategia, e abbiamo anzi avuto troppo immobilismo.
Il Governo Berlusconi era partito come governo liberalizzatore, volto ad alleggerire la presenza pubblica nell’economia e a lasciare spazio agli investimenti privati. (Anche) su questo è difficile mascherare la delusione (acuita da quanto non ha fatto il ministero dell’Industria sulla liberalizzazione delle professioni sull’avvio della Borsa elettrica). Tanti sarebbero i temi, ad esempio la mancata liberalizzazione dei servizi pubblici locali, sulla quale Tremonti sembra avere aderito al partito trasversale degli amministratori locali, molto propensi a difendere le posizioni acquisite, oppure la vicenda delle Autostrade (vedi Ponti 20-01-2004). Ma procediamo con ordine.
Anche se curiosamente proprio le fondazioni sono state protagoniste di una importante operazione, ovvero il passaggio di proprietà del 30 per cento della Cassa depositi e prestiti dal Tesoro alle stesse fondazioni. Una della operazioni pomposamente contrabbandate come privatizzazioni, quasi le fondazioni fossero rappresentanti del rampante capitalismo nazionale
Da un lato, non risulta bisogna darne atto nessuna pesante ingerenza del ministro nell’operato delle grandi imprese rimaste in mano pubblica. Ci piacerebbe poter dire la stessa cosa dei suoi colleghi e alleati, ma questa è un’altra storia.
Tuttavia, anche la non-ingerenza può dar luogo a paradossi. Si pensi al settore energetico, che ora è nell’occhio del ciclone grazie alla offensiva congiunta di Autorità antitrust e Autorità per l’energia. Si accusano Eni ed Enel di tenere prezzi troppo alti ai danni dei consumatori e della competitività del settore privato. Di chi sono Eni ed Enel? I loro amministratori sono nominati dal governo. Non ho certo nostalgie delle ingerenze governative nelle imprese, ma il fatto che siano proprio aziende in mano pubblica a creare (pare) tutti questi problemi all’intero paese, dato il loro orientamento al profitto, sembra un po’ ridicolo.
A fianco di questo, purtroppo si deve invece ricordare la pesante ingerenza nell’attività delle Autorità, la cui indipendenza dà parecchio fastidio. Ma in realtà anche col precedente governo, al momento di fissare le tariffe elettriche gli interessi del proprietario di Enel (il Tesoro) avevano finito per farsi sentire in modo pesante.
Dopo aver detto della gestione delle imprese, passiamo alle privatizzazioni. Quali, diranno i lettori? Bella domanda.
L’unica vera privatizzazione del triennio è la vendita dell’Eti, il monopolio tabacchi; non era proprio una partecipazione strategica, ma almeno su questo il ministero ha operato bene, anche oltre le aspettative, cedendo interamente le sigarette di Stato, per una cifra del tutto ragguardevole (2,3 miliardi di euro), anche se con qualche preoccupazione per la concorrenza in quel mercato sul quale per altro l’Autorità antitrust si è limitata a chiedere alcune correzioni tutto sommato marginali.
Quindi, il controllo pubblico sull’industria resta praticamente invariato rispetto a quello che era all’inizio della legislatura, nonostante un governo sedicente pro-mercato e privatizzatore. Colpa di Tremonti? Da un lato il pessimo periodo del mercato azionario ha costituito talvolta una scusa, ma anche una discreta ragione per rallentare le vendite. Dall’altro, non ricordo di avere sentito molte voci né a destra, né a sinistra favorevoli alla cessione del controllo pubblico delle grandi imprese energetiche. Il consenso politico su questo non sembra proprio esserci, a prescindere dall’identità del ministro di turno. E serpeggia tanta voglia di tornare all’Iri
Tremonti ha oscillato tra Colbert (il padre delle imprese pubbliche francesi) e Margaret Thatcher (la madre delle privatizzazioni inglesi) che è come dire tra il diavolo e l’acqua santa.
Questa contraddizione (vorrei liberalizzare il sistema industriale, ma anche mantenerne il controllo
) ha condannato il governo all’immobilismo per quanto riguarda le quote di proprietà (per non perdere il controllo), ma anche a un curioso non intervento (per non interferire con il processo di mercato). Con il paradosso che abbiamo imprese che restano in mano pubblica, ma si comportano come se fossero private. E allora, ci si chiede, a che serve la proprietà pubblica?
Rimpiangeremo Tremonti? Diciamo che, se è vero che ha vinto il partito delle poltrone nelle imprese pubbliche e degli infiniti buchi di bilancio, il bello viene adesso.
Uno dei pochi punti di consenso tra gli economisti è che il rallentamento economico abbia svolto un ruolo di tutto rilievo nel deterioramento dei conti pubblici dei paesi europei. La più bassa crescita comporta infatti un calo delle entrate e nella maggior parte dei casi (l’Italia, dato lo scarso rilievo degli ammortizzatori sociali, è però un’eccezione al riguardo) anche un aumento delle spese, con effetti negativi sulle finanze pubbliche. La speranza è che la tanto sospirata ripresa economica riesca a riportare un po’ di luce anche sui disastrati conti pubblici italiani tenendoli lontani dalla soglia di Maastricht. Ottimismo fuori luogo Ma sarà proprio così? Purtroppo l’ottimismo, anche in questo caso, rischia di essere fuori luogo. Vediamo perché. Proprio per tenere conto degli effetti del ciclo economico sui conti pubblici, la Commissione europea calcola regolarmente un saldo di bilancio corretto per gli andamenti del ciclo economico e lo utilizza sistematicamente per formulare le proprie raccomandazioni ai paesi membri in termini di politica fiscale. Come viene effettuato il calcolo? Il primo passo è la stima del Pil potenziale, il livello del Pil che si avrebbe se l’economia funzionasse a pieno regime. La differenza fra Pil effettivo e Pil potenziale dà il cosiddetto output gap. Il secondo passo è la stima dell’intensità (l’elasticità, nel gergo degli economisti) con cui entrate e spese primarie (al netto cioè degli interessi) reagiscono a variazioni del Pil. Si calcola infine il saldo di bilancio nell’ipotesi di un output gap pari a zero. Questa misura è nota come disavanzo strutturale, il disavanzo che si avrebbe se il Pil fosse pari al suo potenziale. Nel calcolo, tuttavia, non si tiene conto, presumibilmente per le difficoltà tecniche che ciò comporterebbe, degli effetti del ciclo sulla spesa per interessi. Ma non si tratta di una voce di scarso rilievo, soprattutto per un paese altamente indebitato come l’Italia. In risposta a un aumento dello scarto fra output potenziale e effettivo, la Banca centrale interverrà infatti riducendo i tassi, con un effetto particolarmente favorevole per i paesi altamente indebitati o con un debito sbilanciato verso il breve termine. Se prendiamo per buone le stime disponibili della funzione di reazione della Banca centrale, vediamo che un deterioramento dell’output gap di un punto percentuale induce una riduzione dei tassi perlomeno di 50 punti base (mezzo punto percentuale). A regime, il miglioramento per il disavanzo pubblico di un paese con un rapporto debito/Pil pari al 100 per cento è quindi di circa mezzo punto percentuale: una minore crescita del Pil di un punto dà luogo a un diminuzione del tasso di interesse di mezzo punto che implica una minore spesa per interessi pari ancora a mezzo punto di Pil. Naturalmente l’effetto sulla spesa per interessi non è istantaneo: secondo le stime ufficiali del Tesoro una diminuzione di un punto del tasso di interesse ha un impatto sulla spesa per interessi pari allo 0,23 per cento del Pil dopo un anno, 0,41 per cento del Pil dopo due anni, 0,51 per cento del Pil dopo tre anni. È indubbiamente vero che un peggioramento dell’output gap deprime le entrate e accresce il disavanzo (nel caso dell’Italia la stima è ancora di quasi mezzo punto di Pil per ogni punto di output gap), ma dopo tre anni metà del peggioramento è compensato dal calo della spesa per interessi e dopo circa cinque anni (questo è il tempo necessario perché una variazione dei tassi di interesse si trasferisca interamente sul costo del debito) la compensazione è completa. In conclusione, il metodo di correzione per il ciclo utilizzato dalla Commissione europea e da altre istituzioni internazionali rischia di fornire un quadro eccessivamente ottimista (pessimista) per un paese altamente indebitato come l’Italia durante i periodi di rallentamento (ripresa) dell’economia. Se l’Italia non aggancia la ripresa Ma vi è un altro rischio. Supponiamo che l’Italia manchi, come sembra possibile, l’aggancio con la ripresa europea. Secondo le stime di primavera della Commissione europea la crescita nel 2004 sarà pari all’1,7 per cento per l’area euro ma solo all’1,2 per cento per l’Italia. Anche nel 2005 l’area euro dovrebbe crescere più rapidamente dell’Italia. Le migliorate condizioni economiche nell’area dell’euro, e un’ulteriore stretta’ della Fed, potrebbero indurre la Banca centrale europea ad aumentare i tassi di interesse. Paradossalmente, è del tutto possibile che l’Italia non tragga grande beneficio dalla modesta ripresa a livello nazionale, ma soffra le conseguenze in termini di più alti tassi di interesse della ripresa a livello europeo. Le stime sull’andamento dei conti pubblici dell’Italia rischiano quindi di peccare, nuovamente, di ottimismo. Rimane da sperare che il nuovo Dpef, che dovrebbe essere varato nei prossimi giorni, tenga conto di questi fattori e riesca a fornire un quadro un poco più realista della situazione della nostra finanza pubblica, anche a costo di dovere ammettere che non vi è spazio per gli sgravi fiscali.
Dopo l’equilibrato numero monografico de lavoce.info, consideriamo concluso il momento degli epicedi sul dimissionamento del ministro GiulioTremonti (1) e occupiamoci del futuro. Non di chi gli succederà come autocrate dell’economia e delle finanze; piuttosto dei problemi che il successore, chiunque egli sia, dovrà affrontare. I problemi del successore di Tremonti La premessa è che la questione vera della nostra finanza pubblica non risiede nel numero magico del 3 per cento di disavanzo, ma nella dinamica del rapporto fra debito pubblico e prodotto. Non che esista un obiettivo preciso per questo rapporto. Ma, se il suo livello è e resta particolarmente elevato, i tassi d’interesse sono più alti e i conti pubblici sono più esposti al rischio di una loro variazione; comunque una parte cospicua delle entrate deve essere destinata al pagamento di interessi ai possessori di titoli anziché alla provvista di beni e servizi. Si vorrà riconoscere che il nostro 106 per cento, superiore di 35 punti alla media europea, è molto, troppo alto: con 10 punti in meno, la spesa di interessi si ridurrebbe di mezzo punto di prodotto: di tanto potrebbero essere ridotte le imposte (o, se i cittadini lo preferiscono, di tanto aumentata l’offerta di investimenti e servizi pubblici). Assicurare una continua, anche se graduale, diminuzione del rapporto fra debito e prodotto è dunque un obiettivo importante ed economicamente significativo. Per fissare le idee, e senza troppe ambizioni, chiediamoci a quali condizioni si possa ottenere un calo di due punti all’anno, in modo da avere entro il 2007 un debito non superiore al prodotto nazionale. L’algebra del debito L’algebra elementare del debito ci dice che la dinamica di esso rispetto al prodotto dipende da tre variabili: costo medio del debito, tasso di crescita nominale dell’economia, saldo (primario) fra entrate e spese al netto degli interessi: una differenza positiva fra costo del debito e tasso di crescita fa aumentare il rapporto fra debito e prodotto nazionale; un avanzo primario lo fa diminuire. (2) Ministri e padri di famiglia Come ottenere questo miglioramento? Un aumento della pressione fiscale è improponibile. Occorre dunque intervenire sulla spesa al netto degli interessi, per contenerne la crescita ben al di sotto della crescita dell’economia: compito certo difficile, ma non impossibile nelle dimensioni indicate. Negli ultimi mesi, tuttavia, e da ultimo all’assemblea dell’Abi, il presidente del Consiglio ha ribadito la fermissima intenzione di ridurre la pressione fiscale sui redditi personali, per mantenere le sue promesse elettorali: ha concesso che le aliquote possano essere tre e non due, ma ha anche promesso una qualche riduzione dell’Irap. La ricetta di copertura offerta all’Abi dal presidente-ministro ad interim dell’Economia risiede in un semplice teorema, mutuato, come egli ci ha detto, dalla finanza della famiglia e dell’impresa. Meno soldi entrano, meno si spende: se si tagliano le imposte, ogni buon padre di famiglia e ogni accorto imprenditore dovrà necessariamente tagliare le spese. (1) Due citazioni riassuntive dal Giulio Cesare. Antonio: “Il male che gli uomini fanno sopravvive loro, il bene spesso finisce sotto terra con le loro ossa”. Popolano: “Temo che ve ne sarà uno peggiore al suo posto”. (2) La formuletta, approssimata, è: Dd = (r-g)d a, ove Dd è la variazione del rapporto fra debito e prodotto nazionale, r è il costo medio del debito, g è il tasso di crescita nominale dell’economia, e a è il saldo fra entrate e spese al netto degli interessi, positivo o negativo. Se ad esempio il debito è pari al prodotto e il costo del debito eccede di un punto il tasso di crescita, con un avanzo primario nullo il rapporto cresce di un punto; resta costante con un avanzo primario dell’1 per cento; diminuisce di un punto con un avanzo primario del 2 per cento.
Vi è anche un altro fattore, la differenza fra fabbisogno e indebitamento, che ha contribuito negli ultimi anni ad alimentare, e non di poco, la crescita del debito. Ipotizziamo, a rischio di essere indebitamente ottimisti, che la forbice fra fabbisogno di cassa e indebitamento di competenza si richiuda e ci concentriamo quindi solo sulle prime tre variabili. Supponiamo che l’economia torni a un normale, anche se non esaltante regime di crescita: un’ipotesi del 4 per cento medio annuo (nominale) sembra sensata. Oggi il costo medio del debito è vicino al 5 per cento: a essere benevoli, si può anche supporre che possa abbassarsi sino al 4,5. Dalla formuletta riportata in nota risulta che occorre un avanzo primario stabile dell’ordine del 2,5 per cento del prodotto per ottenere la riduzione di due punti all’anno del rapporto che abbiamo posto come modesto obiettivo (con mezzo punto in meno o in più di avanzo primario per mezzo punto in meno o in più della differenza fra costo del debito e tasso di crescita).
Quale avanzo primario? Poiché stiamo ragionando sul medio periodo, il saldo che ci interessa deve avere natura strutturale: né abbellito da misure una tantum che, per definizione, non possono essere ripetute (anche perché oramai resta ben poco spazio all’inventiva), né ridotto dagli effetti di una congiuntura negativa. Per capire dove ci troviamo ora, usiamo gli utili numeri elaborati da Roberto Perotti nella sua analisi della “macroeconomia di Tremonti”. Nelle plausibili stime di Perotti, l’avanzo primario depurato da misure non ripetibili come i condoni (pari a quasi il 2 per cento del prodotto), ma aggiustato in aumento per tener conto della congiuntura negativa, è stato dell’1,12 per cento nel 2003. Rimarrà probabilmente vicino a quel livello anche nel 2004, sempre che le misure di correzione della recente manovra governativa riescano a compensare il peggioramento in atto (ma secondo il Governatore della Banca d’Italia l’avanzo primario si riduce comunque). Ne segue che, solo per consentire la modesta riduzione del rapporto fra debito e prodotto di cui si è detto, occorre che l’avanzo primario strutturale (depurato da una tantum e da effetti ciclici) migliori nel 2005 e negli anni a venire di ben oltre un punto in termini di prodotto.
Facciamo un po’ di conti. Le promesse del presidente assommano ad almeno un punto e mezzo di prodotto: più o meno tanto quanto sarebbe necessario per ottenere la riduzione del debito di due punti. Per raggiungere entrambi gli obiettivi servirebbero dunque interventi sulla spesa dell’ordine di 35-40 miliardi, pari al 5-6 per cento delle uscite al netto degli interessi. Temo che neppure un ottimo padre di famiglia, quale è il Ragioniere generale dello Stato, Vittorio Grilli, ci riuscirebbe. Il governo si è impegnato a non toccare la spesa previdenziale, e in genere quella sociale; le spese per il pubblico impiego sono obbligatorie; agli investimenti pubblici si assegna priorità; gli acquisti di beni e servizi sono stati drasticamente tagliati con la recente manovra, per evitare un peggioramento (non per ottenere un miglioramento) dell’avanzo primario. Che cosa rimane? La riforma degli incentivi alle imprese potrà rendere al più 10-12 miliardi. E il resto da dove viene? Per saperlo, aspettiamo la pubblicazione del documento di programmazione economica e finanziaria, mai così tardivo. Ma vi sono, temo, pochi dubbi: il resto manca. Se così è, la promessa riduzione della pressione fiscale ordinaria (al netto dei condoni) potrà avvenire solo lasciando dov’era il rapporto fra debito e prodotto o con qualche frazione in meno, se si escogita qualche altro espediente (come la vendita con lease back di immobili pubblici) o si vende qualche gioiello residuo. Dato un limite di fattibilità al contenimento della spesa nel breve periodo, questa è dunque l’alternativa: o una diminuzione del rapporto fra debito e prodotto, che potrà consentire in futuro un calo della pressione fiscale, o una riduzione delle aliquote subito. Forse il padre di famiglia sceglierebbe prudentemente la prima strada, per mettersi al riparo dai rischi di mercato ed evitare le censure internazionali. Ma, a meno di due anni dalle elezioni, conosciamo le preferenze del padrone della famiglia: anche perché, come ha detto nel suo intervento all’Abi, con un debito dell’ordine di 1400 miliardi poco importa averne qualche decina di miliardi in più.
L’articolo, assai pregevole, di Roberto Perotti offre un bilancio dell’operato del ministro Giulio Tremonti. La ricostruzione del passato va però fatta con i dati che erano disponibili in quel momento, non con le informazioni di oggi. Le valutazioni che ne risultano possono essere assai diverse. Il lascito dei governi precedenti Il governo di centrodestra ereditò un processo di aggiustamento fiscale del tutto sbilanciato? È questa la tesi di Perotti secondo cui l’aggiustamento fiscale dei governi precedenti fece uso di misure temporanee, privilegiò l’aumento delle entrate e non incise se non de minimis sulla spesa primaria. Tesi non del tutto convincente se consideriamo che il processo di risanamento fiscale comincia con il governo Amato nel 1992. La Finanziaria di Amato non è però “visibile” negli andamenti effettivi delle uscite in quanto incide sul tendenziale della spesa pensionistica. In assenza di tale correzione, la spesa sociale sarebbe cresciuta, secondo le stime dell’Ocse, di altri 5 punti del Pil. La mera analisi del dato nasconde quindi una correzione radicale dell’andamento dei conti pubblici. E fu proprio il miglioramento del saldo primario indotto dalle misure adottate dai governi precedenti che consentì all’esecutivo guidato da Prodi di intervenire con provvedimenti in gran parte temporanei per accedere all’Unione monetaria e beneficiare di un calo massiccio della spesa per interessi. Semmai la colpa dei governi di centrosinistra è di non avere fatto di più dopo il 1997 per proseguire l’opera di risanamento del bilancio. Furono gli squilibri di bilancio ereditati dal governo precedente (il disavanzo nel 2001, ci ricorda Perotti, si attesta al 2,6 per cento del Pil) che costrinsero il governo di centrodestra a ricorrere massicciamente alle una tantum? Di nuovo si corre il rischio di un errore di prospettiva. Fino a febbraio del 2002 (ben dopo quindi l’attacco alle Torri Gemelle), l’esecutivo di centrodestra era convinto che i conti pubblici fossero sotto controllo, che il disavanzo del 2001 non avrebbe superato l’1,1 per cento e che anche la situazione del 2002 non destasse preoccupazioni (il disavanzo tendenziale per quell’anno veniva stimato all’1,7 per cento dalla Relazione previsionale e programmatica). Ci vorranno più di diciotto mesi di revisioni dell’Istat e di sentenze dell’Eurostat perché il disavanzo del 2001 venga rivisto al 2,6 per cento. Si tratta di un dato quindi che non può avere indotto il governo a orientare la politica fiscale in senso restrittivo né per il 2002 né per il 2003. Semmai è vero il contrario. La sentenza Eurostat di luglio 2002 sulle cartolarizzazioni aggravò il saldo del 2001 per una cifra pari a circa 7 miliardi di euro, ma consentì di contabilizzare tali entrate nel 2002 e nel 2003 riducendo quindi le esigenze di una stretta di bilancio per quegli anni. Rallentamenti dell’economia e tassi d’interesse Le difficoltà di bilancio dopo il 2001 vanno attribuite al rallentamento dell’economia mondiale? Perotti mette in luce come il disavanzo corretto per il ciclo migliori, e di molto, dal 2001 al 2003. Verissimo. Le stime della Commissione pubblicate nell’ultimo rapporto di primavera mettono in luce una riduzione dell’indebitamento strutturale dal 3,2 per cento nel 2001 all’1,9 per cento nel 2003. Ma anche questo dato va considerato con molta cautela, almeno per quattro motivi. In primo luogo, è completamente cambiata la stima dell’output gap, negativo nelle stime formulate a novembre del 2001 (la produzione effettiva era quindi inferiore a quella potenziale e il disavanzo corretto per il ciclo minore di quello effettivo) ma positivo nei dati rivisti successivamente e utilizzati da Perotti. Utilizzando la stima dell’output gap disponibile nel 2001, il disavanzo strutturale di quell’anno scenderebbe di quasi un punto, al 2,3 per cento. In secondo luogo, sul dato del 2001 si concentrano tutta una serie di revisioni, molte delle quali si pensi alla spesa sanitaria andrebbero attribuite ad anni precedenti. Inoltre, tutto il miglioramento del saldo di bilancio strutturale va attribuito al calo della spesa per interessi – 1,2 per cento – a sua volta frutto della riduzione dei tassi di interessi mondiali e non della diminuzione del debito che rimane invece inchiodato su valori ben al di sopra del 100 per cento. Infine, se è vero che l’avanzo primario corretto per il ciclo non peggiora tra il 2001 e il 2003, questo risultato è stato ottenuto con misure tampone, come i condoni, che peseranno, e non poco, sui conti pubblici nei prossimi anni. Il fardello del prossimo ministro In conclusione, sembra difficile sostenere che il governo di centrodestra ereditò da quello precedente una situazione dei conti pubblici fortemente deteriorata o che il rallentamento dell’economia mondiale abbia pesato in maniera determinante sugli andamenti di finanza pubblica dopo il 2001. Se così fosse, tra l’altro, i conti pubblici non registrerebbero un ulteriore e pronunciato deterioramento proprio nel 2004, quando si manifestano i primi segnali di una seppur timida ripresa. L’articolo di Perotti si ferma al 2003 e trascura quindi il periodo in cui i nodi di una politica sbagliata stanno venendo tutti al pettine. Secondo le stime della Commissione, l’avanzo primario corretto per il ciclo si ridurrà infatti nel 2004 di un punto del Pil, circa 13 miliardi di euro. Per il 2005 gli andamenti sarebbero ancora peggiori. Dovremo aspettare il Dpef per avere informazioni al riguardo, anche se è oramai evidente che il nuovo ministro dell’Economia dovrà fare i conti con un disavanzo che, anche in assenza degli sgravi promessi, è ben al di sopra del 4 per cento e di una dinamica del debito palesemente insostenibile.
Come ho cercato di documentare (vedi Perotti) dal lato delle entrate, Tremonti lascia un’immagine di misure improvvisate e di mancanza di trasparenza. Tuttavia, il vero neo della gestione Tremonti sono stati i condoni; per il resto, non è stata molto diversa dalle precedenti. Anche e soprattutto dal lato delle spese la gestione Tremonti non è stata molto diversa dalle precedenti. Non c’è stata alcuna azione decisa per ridurre la spesa, ma questo è vero anche per i governi precedenti. E la spesa non è esplosa, anzi in termini reali essa è aumentata meno che nel periodo precedente, nonostante la situazione ciclica sfavorevole e anche escludendo le entrate una tantum contabilizzate in detrazione di spesa. Perché le una tantum Ma è importante cercare di spiegare perché un editorialista e politico che per anni aveva predicato la semplificazione delle imposte e la chiarezza dei bilanci, una volta diventato ministro abbia fatto ricorso a misure così imbarazzanti quali i condoni. Il motivo immediato è semplice. La riga 14 della tabella 2 (riportata nel mio altro articolo) mostra che l’indebitamento netto sul Pil era nel 2001 pericolosamente vicino alla fatidica soglia del 3 per cento, e in crescita. Per evitare di sforare il Patto di Stabilità e crescita, Tremonti si è trovato nella necessità di ridurre il disavanzo, e in fretta. Ma come? Come abbiamo visto, nessun governo degli ultimi dieci anni in Italia è riuscito a ridurre la spesa primaria, e a maggior ragione in pochi mesi. Ed era irrealistico pensare che un governo che era caduto nel 1994 sulle pensioni avrebbe proposto una riforma delle pensioni seria appena tornato al potere. Era anche difficile pensare che il ministro di un governo eletto in parte su una piattaforma di tagli alle tasse potesse aumentarle. Rimanevano le misure una tantum. E come abbiamo visto, Tremonti non ne ha fatto un uso molto più sfrenato di altri governi che si sono trovati a dover agire in condizioni di crisi o di pressione esterna, come nel 1992-3 o nel 1997. La composizione però è stata diversa, con un’enfasi esagerata sui condoni, per di più male attuati (vedi Guerra). L’alternativa era sforare il Patto in maniera ancora più vistosa. Anche qui Tremonti era tra l’incudine e il martello: se avesse ignorato il Patto, come hanno poi fatto Francia e Germania, probabilmente sarebbe stato accusato di anti-europeismo. Come si è arrivati al 3 percento? La domanda fondamentale è quindi: come si è arrivati a un indebitamento vicino al 3 percento nel 2001? La riga 14 della tabella 2 mostra che, dopo tutto, l’ indebitamento netto era solo il 0,65 per cento nel 2000. Tuttavia, questa cifra è fuorviante, perché risente dei proventi una tantum Umts. Al netto di questi, l’indebitamento netto era già vicino al 2 per cento nel 2000. Al 2,65 per cento del 2001 si è arrivati con il rallentamento della crescita e con misure discrezionali, di cui probabilmente la maggior parte, come abbiamo visto, imputabile al governo precedente. Molti, e la Commissione europea con particolare insistenza, sostengono che i vincoli del Patto non creerebbero problemi se i governi seguissero una semplice regola: diminuire i disavanzi, o addirittura creare degli avanzi di bilancio, in tempi di alta crescita, per permettere ai disavanzi, in tempi di rallentamento ciclico, di crescere senza sorpassare il 3 per cento. Così non è stato: come abbiamo visto, Tremonti ereditò dagli anni buoni un indebitamento netto che era già pericolosamente vicino al 3 per cento. Ancora una volta sarebbe scorretto ignorare il passato. Un’ immagine di improvvisazione Tremonti ha dovuto fronteggiare una doppia emergenza: il rallentamento ciclico, e il Patto che mordeva per la prima volta; tutto questo con veti incrociati degli alleati sulle politiche attuabili. Certo, forse avrebbe potuto gestire meglio l’emergenza. E qui veniamo all’aspetto forse più appariscente della gestione Tremonti. Indubbiamente il ministero ha spesso proiettato, soprattutto all’inizio, un’immagine di impreparazione e di dilettantismo nella gestione della politica economica. L’ esempio più eclatante è probabilmente il primo Dpef del governo Berlusconi del luglio 2001, che, nonostante chiari segnali del rallentamento ciclico, prevedeva un tasso di crescita programmatico del 3,1 percento ogni anno fino al 2006, grazie alle misure di politica economica che il governo avrebbe preso! Questa imbarazzante dimostrazione di incompetenza economica e di cieca credenza in teorie economiche semplicistiche e universalmente screditate potrebbe forse venire classificata benevolmente come una irresponsabile operazione di marketing, se non indicasse che il governo si fece cogliere largamente impreparato dagli eventi seguenti, sprecando mesi preziosi a inseguire fantasmi. Ma a onor del vero Tremonti e i suoi collaboratori erano ancora una volta in buona compagnia, in termini di sostanza se non di forma. Solo pochi mesi prima, alla fine di settembre del 2000, la nota di aggiornamento al Dpef prevedeva un indebitamento netto, grazie alla manovra messa in atto da quel governo, del 0,9 percento del Pil nel 2001 quasi 2 punti percentuali sotto quello realizzato – e addirittura dello 0 per cento nel 2003! Un secondo esempio fra i tanti è la saga senza fine degli incentivi alle imprese e al Sud, sottoposti a una decretazione incontinente, con un alternarsi continuo di messaggi contrastanti e di cambiamenti di direzione, che hanno svilito e complicato ulteriormente degli strumenti già largamente screditati e incomprensibili. Ma anche in questo caso, niente di nuovo sotto il sole; l’approccio al Sud non è cambiato, sono forse cambiati leggermente gli strumenti preferiti – e ugualmente inefficaci. Indubbiamente da Tremonti ci si aspettava di più: misurata contro le aspettative, la gestione Tremonti può essere vista come una delusione. Ma misurata contro molti predecessori, e tenuto conto del ciclo economico, è ben lungi dall’essere stata un disastro.
Che conti pubblici ci lascia Tremonti? Prima di tentare un bilancio, è importante stabilire i fatti. Le entrate: i condoni, e il resto Partiamo dalle entrate. Tremonti rischia di venire ricordato per l’uso massiccio di misure una tantum. La tabella 1 mostra il dettaglio delle misure una tantum durante la gestione Tremonti e nei periodi precedenti. (1) Le anticipazioni di entrate sono una cosa diversa. Consistono soprattutto nelle cartolarizzazioni immobiliari, una misura di qualche rilevanza solo nel 2002 quando valse lo 0,5 per cento del Pil. Con questo meccanismo, le Ap cedono degli immobili a una società veicolo, a fronte di una somma che presumibilmente rappresenta il valore atteso ricavabile dalla vendita di questi immobili a privati in futuro. Da un punto di vista macroeconomico, le anticipazioni di entrate rappresentano essenzialmente un cambiamento del profilo temporale delle entrate nette (più alte oggi, più basse domani), senza necessariamente cambiarne il valore atteso. In questo senso, non hanno necessariamente una grande rilevanza macroeconomica, ma sono ovviamente molto utili per soddisfare i vincoli del Patto. Questo in teoria. In pratica, hanno infatti due tipi di costi, anche se difficilmente quantificabili: riducono la trasparenza dei bilanci, e possono comportare un costo implicito maggiore del tasso di interesse che le Ap oggi pagano sul debito pubblico (vedi Pisauro 06-05-2003). Anche le entrate straordinarie e occasionali (cessioni di immobili, prelievi sostitutivi straordinari, versamenti per le rivalutazioni dei cespiti aziendali) sono state usate in misura limitata (tra lo 0,4 e lo 0,55 del Pil a seconda degli anni), e comparabile a simili occasioni in passato: per esempio, l’Eurotassa del 1997-8 valeva circa l’1 per cento del Pil. Qualunque sia il giudizio che si dà sulla loro trasparenza e opportunità, è importante quindi tenere presente che i risultati discussi qui non dipendono da queste misure. Le spese: alcuni miti, e la realtà Consideriamo ora il lato delle spese della gestione Tremonti. Partiamo dal dato aggregato, la spesa primaria (cioè al netto degli interessi). Qui sorgono due difficoltà. La prima è quale anno prendere come punto di partenza: il 2000 o il 2001? Il secondo risente dell’attività di due governi diversi, che si dividono l’anno quasi a metà. Per i motivi che discuto sotto, il 2001 è probabilmente un migliore punto di riferimento. La seconda difficoltà è che i dati ufficiali sulla spesa primaria possono essere fuorvianti, perché per convenzione le spese in conto capitale sono al netto di alcune entrate una tantum, come le vendite e cartolarizzazioni di immobili e i proventi Umts (vedi tabella 1). (5) Le righe 1 e 2 della tabella 2 presentano l’andamento del rapporto spesa primaria/Pil, sia quello originale sia quello, più significativo, “corretto” escludendo appunto le entrate una tantum portate in detrazione alle spese in conto capitale. La spesa primaria ufficiale del 2003 è più alta di 1,7 punti percentuali del Pil rispetto al 2001 e di 3,4 punti percentuali rispetto al 2000 (che beneficiò dei proventi Umts); per quella corretta, i numeri sono 1,7 e 2,4 punti percentuali. Due voci di bilancio rappresentano quasi l’85 per cento di tutta la spesa primaria: consumi pubblici (cioè consumi intermedi più remunerazione degli impiegati pubblici, o spesa per il personale) e prestazioni sociali alle famiglie. L’andamento di queste due voci è dunque cruciale per comprendere la dinamica delle spese; fortunatamente, inoltre, i dati su queste due voci sono abbastanza incontroversi, ed esenti da interpretazioni alternative e alchimie contabili. La spesa per consumi pubblici nel 2003 è aumentata rispetto al 2001 dello 0,5 percento del Pil. Di questi, solo 0,2 punti percentuali sono dovuti all’ aumento della spesa per personale. Ciò sembra contrastare con l’opinione diffusa che la spesa per consumi intermedi e per il personale stesse aumentando fuori controllo, con aumenti nel 2003 rispettivamente del 19,5 per cento e del 9,3 per cento. Il motivo della apparente contraddizione è semplice: questi ultimi dati si riferiscono al settore statale, e sono di cassa; inoltre, omettono il fatto che nel 2002 la spese per consumi intermedi e per il personale del settore statale diminuirono dell’2,4 e dell’1,3 per cento, rispettivamente. Il primo dato si riferisce alle Ap, ed è di competenza. Come spiegare allora l’aumento considerevole 1 punto percentuale del Pil dei consumi pubblici nel 2003 rispetto al 2000? Metà di questo aumento è avvenuto nel 2001, ed è imputabile in gran parte all’aumento della spesa sanitaria (15,9 per cento) e in particolare di quella farmaceutica (32,8 per cento). È difficile attribuire esattamente la responsabilita’ di questo aumento, ma certamente su esso hanno influito pesantemente le misure prese dal governo precedente nella prima parte dell’ anno, quali l’ abolizione del ticket e l’ ampliamento delle prestazioni garantite dal SSN. La spesa per prestazioni sociali monetarie nel 2003 è aumentata di 0,4 pp rispetto al 2000, e di 0,6 pp rispetto al 2001. L’ aumento è dovuto soprattutto alla spesa pensionistica, in parte a causa delle tendenze demografiche in atto, in parte per misure discrezionali quali l’ aumento delle pensioni minime. È legittimo incolpare Tremonti di parte di questo aumento, ma bisogna allora essere coerenti fino in fondo: molti di coloro che invece accusano questo governo di irresponsabilità fiscale e di tradire il Trattato di Maastricht allo stesso tempo lo accusano di volere attaccare lo stato sociale. Sono davvero aumentate le spese? I dati su entrate e spese in relazione al Pil sono però leggermente fuorvianti. È importante ricordare che il ciclo economico (vedi riga 20 della tabella 2) è stato negativo nel 2002-2003 e positivo (almeno per gli standard italiani) nel 1995-2001. Un peggioramento della congiuntura fa aumentare spese ed entrate in rapporto al Pil semplicemente perché fa diminuire il denominatore. Per avere un’idea dell’effetto denominatore sulle spese, le righe dalla 8 alla 13 della tabella mostrano i tassi di crescita in termini reali (valori nominali divisi per il deflattore del Pil) delle voci di spesa analizzate in precedenza. Nel 2002 e 2003, la crescita della spesa primaria corretta e dei consumi pubblici (inclusa la spesa per personale) è stata più bassa che nel biennio precedente. Peggio del resto d’Europa? Dipende
Sia per le spese, sia soprattutto per le entrate il ciclo economico impatta anche sul numeratore del rapporto. Un modo per tenerne conto è di esprimere entrate e spese al netto dell’effetto del ciclo economico, ottenendo così dati “cyclically adjusted”. (6) L’avanzo primario “cyclically adjusted” corretto per le misure una tantum è sceso di 1,5 punti percentuali fra il 2001 e il 2003 (riga 19). (8)
.E dei suoi predecessori? Probabilmente no In ogni caso, non si può disconoscere che è mancata sotto Tremonti una politica di riduzione della spesa primaria. In questo, tuttavia, Tremonti è in ottima compagnia. Dalle righe 1 e 14 della tabella 2, si può notare che neanche nel periodo di massimo sforzo per entrare nell’unione monetaria, tra il 1995 e il 1999, quando l’indebitamento netto delle AP cadde dal 7.6 all’1,7 e il ciclo economico era in larga parte favorevole, vi fu la pur minima riduzione della spesa primaria: tutto l’aggiustamento fiscale fu fatto dal lato delle entrate, e anche in questo caso con ampio ricorso a misure una tantum. Il debito pubblico: la fantasia al potere Si afferma frequentemente che la discesa del debito pubblico è rallentata sotto la gestione Tremonti. Anche in questo caso la differenza è spiegabile in gran parte con l’effetto denominatore; ma soprattutto in questo caso, gli artifici contabili hanno contribuito a salvare le apparenze. È infatti sul debito che si è scatenata maggiormente la fantasia del ministero dell’Economia. Anche in questo caso bisogna distinguere tra aspetti contabili ed effetti macroeconomici. Per un cittadino, ciò che conta è il debito pubblico totale di tutti gli enti che sono sotto il controllo pubblico: che questi enti siano formalmente società per azioni, o siano invece parte delle Ap, è irrilevante. Allo stesso modo, il fatto che certi proventi siano cartolarizzati e per di più venduti a enti privati solo di nome, ma in realtà controllati integralmente dal ministero non cambia il valore atteso delle tasse che il governo prima o poi chiederà per pagare il debito. L’impatto macroeconomico diretto di questi artifici contabili è dunque probabilmente limitato. Ma il loro costo, in termini di immagine e trasparenza, potrebbe rivelarsi alto; e in questo senso il loro impatto macroeconomico indiretto potrebbe non essere trascurabile. (1) Questi ultimi sono desunti da varie “Relazioni del Governatore della Banca d’Italia”. Fonte: righe 1-16: “Relazione del Governatore della Banca d’ Italia”, varie edizioni
Sono incluse solo le misure che effettivamente contribuiscono a ridurre l’indebitamento netto (2) delle amministrazioni pubbliche (Ap) (3), il dato rilevante sia per i parametri del Patto di stabilità e crescita, sia per gli effetti macroeconomici. In media, le misure una tantum sono valse circa 1,3 punti percentuali del Pil all’anno durante il periodo 2001-2003, contro una media degli anni precedenti di 0,75 punti percentuali.
È importante però distinguere tre tipi di misure una tantum: condoni, anticipazioni di entrate, ed entrate straordinarie e occasionali.
I condoni sono una manifestazione delle famose “tre i”: “immoralità”, “inciviltà”, e “incompetenza”. Hanno svolto egregiamente il compito di fare cassa in fretta; ma il prezzo da pagare (sebbene non quantificabile) è stato altissimo in termini di immagine e di cultura della semi-illegalità (vedi Guerra). La tabella 1 mostra che i condoni sono la vera anomalia della gestione Tremonti: ben l,5 percento del Pil nel 2003: se si escludono i condoni, la gestione Tremonti mostra una media di misure una tantum simile agli anni precedenti.
Vi sono però due osservazioni più generali sulle misure una tantum. Primo, alcune delle operazioni che più hanno fatto notizia, come le cartolarizzazioni immobiliari e dei proventi del Lotto del 2001, lo swap del debito e le cartolarizzazioni dei crediti Inpdap e della Cassa depositi e prestiti del 2002, e le cartolarizzazioni dei crediti Inps del 2002 e 2003, hanno inciso sul fabbisogno di cassa e sul debito e in misura rilevante, circa 2 punti di Pil nel 2002 e 2003; tuttavia, esse non hanno inciso sull’indebitamento netto. (4)
Secondo, la vendita di immobili pubblici può essere un’operazione perfettamente legittima e opportuna. È anche tutto sommato comprensibile che, sotto pressione per soddisfare gli impegni del Patto, un ministro delle Finanze cerchi di anticipare introiti futuri. Il vero problema è che le dismissioni e le cartolarizzazioni immobiliari sono state in gran parte virtuali, cioè hanno coinvolto società solo legalmente al di fuori delle Ap, in realtà controllate dal Tesoro. Come spiegano (Pisauro 01-03-2004 e Bayron 12-12-2002), non è ovvio che queste società riusciranno a vendere a privati nei prezzi impliciti nelle cartolarizzazioni.
La riga 17 della tabella 2 mostra che indebitamento netto “cyclically adjusted” calcolato dalla Commissione è addirittura diminuito tra il 2001 e il 2003.
Si può obiettare che ciò è avvenuto per la provvidenziale discesa dei tassi di interesse e per l’uso di misure una tantum, condoni, e artifici contabili. Come indica la riga 7, tra il 2001 e il 2003 la spesa per interessi è diminuita dell1,1 per cento del Pil. Al netto di questa spesa, rimane vero che l’avanzo primario “cyclically adjusted” è rimasto essenzialmente invariato tra il 2001 e il 2003 (riga 18 della tabella 2). (7)
Anche questa diminuzione è simile a quella avvenuta nel periodo 1997-2000.
In conclusione, includendo le misure una tantum, Tremonti ha fatto meglio della media dell’area euro, in cui l’ avanzo primario “cyclically adjusted” è sceso tra il 2001 e il 2003 di 0,4 punti percentuali secondo i calcoli della Commissione. Al netto delle misure una tantum, l’avanzo primario corretto per il ciclo è invece andato peggio della media dell’area euro. (9)
Il giudizio finale, quindi, verte sulla legittimità delle misure una tantum. Come ho detto prima, non tutte sono necessariamente negative; ma il ruolo dei condoni nel salvare il 2003 è rilevante.
Anche in questo caso si possono distinguere due strategie: anticipare entrate, portando i proventi in riduzione del debito, e modificare lo status legale di alcune entità per farle uscire dalla definizione delle Ap. Riguardo alla prima, mentre come abbiamo visto solo una parte delle cartolarizzazioni ha avuto effetti dell’indebitamento netto, tutte hanno avuto effetti sul debito delle Ap, anche in questo caso il dato rilevante per il Patto. Riguardo alla seconda, la “privatizzazione” della Cassa depositi e prestiti è emblematica. Di per sé, questa ha portato una minima riduzione del debito (0,6 miliardi di euro). Tuttavia, una volta privatizzata la Cassa, il governo ha potuto “venderle” 11 miliardi di euro di partecipazioni azionarie, e portare il ricavato in riduzione del debito.
È interessante notare come, nella motivazione del downgrading del debito pubblico (http://www2.standardandpoors.com/NASApp/cs/ContentServerpagename=sp/Page/HomePg) annunciata mercoledì 7 luglio, Standard & Poor’s menzioni molto raramente il debito, e si concentri prevalentemente sul disavanzo di bilancio: gli artifici contabili sul debito servono a soddisfare formalmente il Patto, ma non ingannano nessuno.
(2) L’ indebitamento netto è all’incirca la differenza fra uscite ed entrate di competenza.
(3) Le amministrazioni pubbliche includono il settore statale (cui si riferisce il bilancio dello Stato) ma anche Regioni, province, comuni, enti di previdenza, ed altri enti. I dati delle amministrazioni pubbliche, incluso l’indebitamento netto, sono per competenza, quelli sul settore statale quasi sempre di cassa. Molti equivoci sarebbero stati evitati se i media fossero consapevoli della enorme differenza fra i dati delle amministrazioni pubbliche e quelli del settore statale, e della diversa copertura dei vari documenti economici prodotti durante l’anno.
(4) Nelle intenzioni, le prime due misure dovevano ridurre anche l’indebitamento, ma non sono state accettate da Eurostat.
(5) La tabella 1 mostra che il totale di queste entrate in detrazione di spesa è stato dell’1,3 per cento nel 2000 e dello 0,9 percento nel 2002, e trascurabile nel 2001 e 2003. È importante ricordare che questo non è un trucco contabile di Tremonti, ma una convenzione adottata da tutti i paesi europei e incorporata in tutti i dati ufficiali, inclusi quelli certificati da Eurostat e usati per il calcolo dei parametri del Patto di stabilità e crescita.
(6) L’aggiustamento ciclico dei dati di bilancio non è una semplice operazione contabile, ma comporta dei giudizi soggettivi. Di conseguenza, diverse organizzazioni (Ocse, Commissione europea, Fondo Monetario, Banca d’Italia) possono fornire stime diverse dell’aggiustamento ciclico nello stesso anno.
(7) L’opinione diffusa secondo cui la discesa dei tassi è stata resa possibile dall’adesione alla unione monetaria è inoltre un poco maliziosa. Secondo i calcoli di Lorenzo Codogno, Carlo Favero, e Alessandro Missale (“EMU and government bond spreads”, Economic Policy, October 2003), l’adesione all’euro, eliminando il rischio di cambio, ha diminuito il differenziale con i tassi a lunga tedeschi di circa 300 punti base (3 punti percentuali) un numero molto alto. Ma dal 2000 in poi, il differenziale con i tassi tedeschi ha sempre fluttuato tra i 20 e i 40 punti base: in altre parole, gli effetti dell’entrata nell’unione monetaria si sono esauriti ben prima della gestione Tremonti. I tassi di mercato italiani ed europei sono in gran parte decisi dalla Fed americana, che tra il maggio 2000 e la fine del 2003 ha ridotto il Federal Fund rate dal 6,5 per cento all’1 per cento.
(8) Questo dato probabilmente sottostima l’effetto negativo dei fattori esterni sull’indebitamento netto. Con la fine del boom di Borsa, tra il 2000 e il 2003 le Ap hanno perso di colpo circa 8 miliardi di euro (circa lo 0,6 percento del Pil del 2001) in imposte legate all’andamento del mercato borsistico. L’aggiustamento ciclico del deficit tiene conto della caduta del tasso di crescita del Pil, ma non della caduta delle quotazioni di Borsa.
(9) In quest’ultimo confronto, non si tiene conto che anche altri paesi europei hanno fatto uso di misure una tantum, seppure in misura minore.

righe 17-20: “Public Finance in EMU”, edizione 2004, Bruxelles, Commissione europea
Per gli anni 1995 e 1996, nelle righe 16 e 19 si è assunto che le misure temporanee fossero pari a 0,5 punti percentuali del Pil, ottenuto dividendo in tre parti uguali il dato aggregato di 1,5 punti percentuali per il triennio 1994-96 citato dalla “Relazione del Governatore per l’ Esercizio 1999”, p. 177.
La riforma fiscale, annunciata in campagna elettorale, per la quale aveva presentato un disegno di legge delega già nel dicembre del 2001: questa doveva essere l’eredità di Giulio Tremonti alla fine del suo mandato. Le sue dimissioni lasciano invece il “progetto” incompiuto. La riforma annunciata Due elementi hanno impedito a Tremonti di procedere nella sua riforma. In primo luogo, si trattava di una riforma costosissima: l’abolizione dell’Irap, 30 miliardi di euro, la riforma dell’Irpef, altri 20 miliardi di euro. Ma non sono solo i vincoli di bilancio che hanno costretto Tremonti a procedere a piccoli passi: un primo modulo di riforma dell’Irpef, la riforma della tassazione dei redditi delle società. L’altra importante ragione è che la legge delega, approvata, pur senza particolari modifiche rispetto al testo originale, dal Parlamento ben sedici mesi dopo la sua presentazione (aprile 2003), con la sola eccezione della parte relativa alla tassazione del reddito di impresa, non è una vera legge delega. È un manifesto di intenti, poco più o poco meno di una piattaforma elettorale. Quando si è trattato di tradurlo in una riforma vera, i nodi sono venuti al pettine. Solo allora gli alleati di governo, che pure l’avevano votata compatti, si sono resi conto degli effetti redistributivi fortemente negativi del passaggio a un’imposta sui redditi a due aliquote, 23 e 33 per cento. Effetti che erano stati ampiamente segnalati dalla letteratura sull’argomento, ma che non erano emersi con chiarezza nell’attuazione del primo modulo, costoso sì, ma abbastanza neutrale sul piano distributivo. La maggioranza ha cominciato ad andare in ordine sparso, quando ha realizzato che la menzione di una generica volontà di tener conto della famiglia non significa niente: occorre decidere se l’unità di riferimento deve o meno rimanere l’individuo, e, soprattutto, occorre affrontare il problema dell’incapienza fiscale. Alzare le deduzioni o le detrazioni per carichi di famiglia, non dà alcun beneficio (o lo dà solo in misura ridotta) agli individui poveri che non hanno sufficiente imponibile o imposte contro cui farle valere. Allo stesso modo, si sono scontrati con l’insostenibilità della promessa di abolire l’Irap, senza procedere alla ben che minima indicazione di un prelievo che possa sostituirla nel finanziamento delle Regioni (e quindi della sanità). Questi ostacoli, oltre a quello della perdita di gettito, che qualcuno ritiene ancora aggirabile, hanno impedito a Tremonti di realizzare la sua riforma. E non lo renderanno facile neppure al suo attuale successore, Silvio Berlusconi. Il taglio delle tasse che si autofinanzia Fra i provvedimenti più significativi che Tremonti ha comunque realizzato nel triennio in cui è stato ministro, merita di essere ricordato il reiterato ricorso alla strategia del taglio delle tasse, finanziato temporaneamente con entrate straordinarie, con l’obiettivo di attivare un circolo virtuoso, taglio delle tasse- sviluppo economico-aumento delle tasse indotto dalla crescita, che nella sua filosofia avrebbero dovuto permettere al taglio stesso di autofinanziarsi. Lo ha fatto da subito, con la manovra dei cento giorni, il cui cardine, la “Tremonti bis“, era stato il cavallo di battaglia della sua campagna elettorale presso gli industriali e i commercianti. Si è trattato di un’agevolazione non selettiva, indifferentemente concessa a qualsiasi tipo di investimenti, nuovi o di rimpiazzo, di tutti gli operatori economici (compresi i lavoratori autonomi, le banche e le assicurazioni), comunque finanziati, e quindi anche con debito, alla condizione che risultassero superiori, nell’esercizio considerato, alla media degli investimenti realizzati nei precedenti cinque periodi di imposta. Lo ha fatto poi con l’introduzione del cosiddetto primo modulo della riforma dell’Irpef: rimodulazione delle aliquote e introduzione di una deduzione di base, denominata no tax area, in sostituzione della preesistente detrazione per lavoro dipendente e autonomo. Doveva essere la parte della riforma dell’Irpef maggiormente concentrata sui redditi medio bassi, a più alta propensione al consumo, ed essere quindi, a un tempo, redistributiva e di stimolo ai consumi. In entrambi i casi, l’atteso sostegno alla domanda non è venuto, anche a causa della congiuntura economica sfavorevole. Non sono però pochi i contribuenti per i quali la Tremonti bis si è tradotta in un contributo a fondo perduto per sostituire l’auto o l’arredamento dell’ufficio. E non sono state le famiglie più povere (e a più alta propensione al consumo) a beneficiare maggiormente dello sgravio Irpef: secondo le stime del Capp (Cfr. Baldini e Bosi), il 63 per cento di tale sgravio è andato alle famiglie comprese nei decili dal sesto al decimo. Le famiglie più povere, quelle del primo decile, non ne hanno goduto in misura rilevante, in larga parte perché incapienti. Mentre la Tremonti bis ha tagliato le imposte solo temporaneamente, il primo modulo dell’Irpef ha comportato un taglio permanente di imposte: 5,5, miliardi che mancheranno ogni anno alle casse dello stato. Un taglio che richiede una copertura anch’essa permanente (riduzione di spese? aumento di tasse?) che non è ancora stata trovata. Questo problema viene tranquillamente ignorato nel dibattito attuale in cui viene menzionato, esclusivamente, il problema della copertura di eventuali ulteriori tagli fiscali. Le entrate straordinarie: scudo fiscale e condoni La copertura dei tagli fiscali è stata ottenuta, inizialmente, con entrate straordinarie. Quelle a cui ha fatto ricorso Tremonti hanno avuto caratteristiche particolari, su alcune delle quali è bene soffermarsi.
Nel settembre 2001, al duplice scopo di stimolare lo sviluppo economico e di acquisire gettito per finanziare la Tremonti bis, veniva sperimentata la prima edizione dello scudo fiscale, un provvedimento finalizzato a incentivare il rientro o, comunque, l’emersione di capitali illecitamente esportati all’estero, coadiuvato dalle nuove norme sul falso in bilancio.
Pagando una piccola tassa, il contribuente si precostituiva una franchigia (lo scudo, appunto) di ammontare pari all’importo dei capitali emersi o rientrati da opporre all’amministrazione finanziaria in caso di eventuali futuri accertamenti fiscali e previdenziali relativi a periodi precedenti. Larga parte dei capitali che hanno beneficiato dello scudo non sono rimpatriati, se non temporaneamente (vedi Cottarelli), e non hanno quindi contribuito a finanziare lo sviluppo. Molti invece sembrano essere stati i casi di frode: promotori finanziari che si sono prestati al riciclaggio di proventi derivanti dall’evasione fiscale e da altre attività illecite, realizzato proprio grazie al meccanismo dello scudo fiscale. Questo rischio era stato paventato da molti esperti al momento dell’ emanazione della legge, ma ignorato dalle autorità.
L’anno dopo, il finanziamento è arrivato da uno strumento vecchio, a cui anche governi passati hanno fatto ricorso: il condono. Non si è trattato però né di un solo condono, né di un condono qualsiasi. In questo campo infatti il ministro Tremonti ha superato di gran lunga la fantasia dei suoi predecessori. Non solo per la varietà di condoni previsti (cfr Giannini), non solo nel lasciare che venissero di fatto annunciati ancora prima della chiusura dei termini per la dichiarazione a cui si riferivano, ma anche introducendo un’importante innovazione mutuata dai provvedimenti per il rientro dei capitali: la possibilità di fare il condono mantenendo l’anonimato.
Le conseguenze di questi provvedimenti sull’attività di accertamento sono state e saranno molto gravi. Quelle del passato sono state svendute a basso prezzo (come nel caso del provvedimento di “rottamazione” dei ruoli che ha concesso la possibilità di estinguere le pretese del fisco pagando soltanto il 25 per cento delle somme complessivamente dovute). L’attività corrente di accertamento è stata inibita dal continuo spostamento dei termini per l’adesione alle diverse sanatorie. Negli anni a venire, infine, l’amministrazione si troverà per molto tempo nella situazione di condurre accertamenti al buio, per poi scoprire che il soggetto su cui sta indagando non è perseguibile perché si è avvalso di sanatorie anonime (scudo fiscale, condono tombale), o può comunque beneficiare delle diverse franchigie concesse nei confronti degli accertamenti futuri. Proprio lo strumento della franchigia si è infine tradotto in legittimazione, ex ante, all’evasione, nel caso del concordato “preventivo” varato con la Finanziaria per il 2004: il contribuente che aderisce al concordato potrà poi dichiarare un reddito inferiore al vero avendo la garanzia che non sarà sottoposto ad accertamento fintantoché il reddito occultato non supera di oltre il 50 per cento quello dichiarato (vedi Guerra).
In questi anni, in definitiva, l’attività di accertamento dell’amministrazione sembra confinata a svolgere un avvilente ruolo di strumento di ricatto, sollecitata come è a inasprire i controlli sui soggetti che non hanno aderito a questo o quel condono, magari perché onesti. In compenso, i contribuenti disonesti si trovano a godere di benefici inattesi: se avevano contabilizzato fatture false, facendo emergere falsi crediti Iva, aderendo al condono vedranno tali crediti trasformarsi in crediti veri, che il fisco pagherà. Lo svilimento del ruolo dell’amministrazione finanziaria, il condono che legittima un atto illecito, il condono che delegittima le imposte quale strumento democratico di finanziamento della cosa pubblica: questa è l’eredità, certamente più pesante di quella dei conti in disordine, che Tremonti lascia ai suoi successori e al paese.
Come Jacques Necker, ministro delle Finanze di Luigi XVI, Giulio Tremonti ha goduto di un grande potere. Come Necker, Tremonti ha finito per essere vittima delle sue stesse creazioni. È stato il ministro delle una tantum. E di una tantum oggi perisce. Ha giocato d’azzardo sperando in una ripresa del ciclo e in un allentamento dei vincoli europei. E ha perso. Ci lascia un eredità pesante. Ma le sue dimissioni rischiano di spianare la strada al peggiore dei cicli politici. Potremo anche rimpiangerlo. Il potere di Tremonti Tremonti è stato il primo ministro dell’Economia della storia repubblicana, il che gli ha permesso di accorpare su di sé le funzioni precedentemente ricoperte dai titolari del ministero del Tesoro e delle Finanze e, se vogliamo risalire indietro nel tempo, dai ministeri delle Partecipazioni Statali e del Bilancio e della Programmazione Economica. È stato ministro di un governo con la più solida maggioranza parlamentare (in entrambi i rami del Parlamento) dopo il sesto Governo De Gasperi. Ha potuto gestire la politica economica del Governo Berlusconi avendo di fronte a sé un’associazione degli industriali molto arrendevole. Ha dovuto fronteggiare un sindacato non disposto a concedere sconti, ma anche fortemente diviso al suo interno. Nonostante dovesse attuare un programma che prevedeva una forte riduzione delle tasse e della spesa pubblica, è riuscito in questi anni solo a espandere la spesa, cresciuta di ben due punti del Pil. La congiuntura non è stata per lui particolarmente favorevole, ma neanche così ostile come spesso paventato. È più facile tagliare le tasse e la spesa pubblica in periodi di crescita economica. Ma sotto il suo regno è continuata la discesa dei tassi di interesse, una manna per chi deve gestire il “terzo debito pubblico del pianeta”. Sarà più difficile il compito del suo successore, adesso che si è interrotta la fase dei tassi calanti. Vittima delle sue creazioni Tremonti è stato di una fantasia rara nell’inventare misure una tantum, un genio nella finanza creativa. Questo ha permesso al nostro paese di rispettare i vincoli presi a livello europeo. Non è stato certo il primo a usare le una tantum (ce ne sono state anche nella passata legislatura), ma senz’altro il più assiduo. Nelle sue intenzioni, sarebbero dovute servire a guadagnare tempo, in attesa di momenti migliori. Ma il rinvio dei problemi agli esercizi futuri e la finanza creativa hanno finito per allentare anche i vincoli di bilancio percepiti all’interno della coalizione, permettendo agli alleati di governo di sottoscrivere accordi per il pubblico impiego che recepivano in pieno la piattaforma sindacale. E quando il quadro preoccupante dei conti pubblici è risultato evidente a tutti, è stato facile per gli alleati incolpare Tremonti di averli truccati. Sotto la sua reggenza dell’Ecofin, si è consumata la rottura del Patto di Stabilità e crescita, con la riunione dei ministri delle Finanze dell’Unione che ha deciso di non applicare le sanzioni a Francia e Germania in cambio di un atteggiamento più morbido nei confronti dell’Italia (quello che oggi ci ha permesso di evitare l’early warning). Il messaggio secondo cui le regole ci sono solo per non essere applicate, il protratto sforamento dei vincoli di Maastricht da parte dei nostri principali partner europei hanno, di fatto, indebolito l’azione di Tremonti sul fronte interno. È stato costretto a dimettersi alla vigilia di una riunione Ecofin decisiva per il nostro paese. Segnale chiaro del fatto che i vincoli europei non sono stati presi troppo sul serio da molti ministri. Un’eredità pesante Abbiamo documentato su questo sito lo stato attuale dei conti pubblici. Il consuntivo degli ultimi tre anni è sintetizzato in un dato: il saldo primario della Pa nel 2003 è stato peggiore di 1,7 punti di Pil rispetto al risultato del 2000. Solo la riduzione della spesa per interessi (1,2 punti di Pil), il dividendo dell’euro, ha consentito di mantenere il disavanzo complessivo al di sotto della soglia del 3 per cento. Di fronte a un prevedibile rialzo dei tassi, bisognerà ridurre la spesa primaria che, invece, ha ripreso a crescere (un punto nel solo 2003), dopo essere rimasta costante tra il 1996 e il 2000. Non tanto per nuove misure, ma perché l’azione di contrasto è stata debole, basata su interventi tampone (vedi taglia-spese), con lenti progressi nella costruzione di un moderno sistema di monitoraggio e controllo (come testimonia la diatriba tra Tesoro e Banca d’Italia sull’emersione di nuovo debito pubblico alla fine dello scorso anno vedi Perotti) e di un compiuto sistema di relazioni finanziarie tra Stato centrale e autonomie territoriali. Anche le entrate sono cresciute (due punti di Pil rispetto al 2000) sotto la reggenza Tremonti, ma è una crescita che contiene i germi di andamenti molto meno favorevoli in futuro. La successione di condoni ha fortemente incrinato il rapporto tra fisco e contribuenti (vedi Bordignon). Segnali evidenti sull’andamento delle entrate “strutturali” (al netto dei condoni) sono presenti già nel 2003. L’aumento dell’evasione, per una sorta di contrappasso, potrebbe divenire la pietra tombale sulle ipotesi di riduzione delle aliquote dell’Irpef. Buona parte delle entrate aggiuntive è venuta dai proventi della vendita del patrimonio pubblico, non destinati a ridurre il debito, ma solo a tenere insieme l’equilibrio dei conti. Anche qui con costi potenziali non trascurabili (vedi Scip2). Negli ultimi mesi il gioco d’azzardo, la politica dell’attesa di tempi migliori è divenuta insostenibile: il disavanzo viaggia verso il 4 per cento del Pil e il tempo per mantenere le promesse elettorali si sta esaurendo. Cosa accadrà ora? Difficile cercare di leggere nella sfera di cristallo, almeno fin quando non si saprà chi sostituirà Tremonti. Ma una cosa è certa: chiunque siederà alla scrivania di Quintino Sella in via XX Settembre, magari in affitto, difficilmente potrà accentrare su di sé lo stesso potere del suo predecessore e vivrà in un clima di assalto alla diligenza. Dietro alla richiesta di collegialità, si legge un tentativo di procedere a uno smembramento delle competenze del ministro dell’Economia, con la ricostruzione di fatto del dualismo fra Finanze e Tesoro e si parla anche di un ministero per il Mezzogiorno. Una collegialità virtuosa può invece venire da una maggiore trasparenza della politica di bilancio che renda il vincolo finanziario chiaramente percepibile a tutti: ministri, gruppi di interesse e opinione pubblica. Per evitare il saccheggio del bilancio pubblico è necessario un sistema di regole rigide e una “casa di vetro”. Varranno poi per il successore di Tremonti le leggi del ciclo politico, che comportano un aumento del deficit pubblico di circa mezzo punto di Pil in occasione di ogni tornata elettorale. Tremonti sembrava in procinto di gestire il ciclo politico riducendo le tasse, anche senza copertura. Nel suo mesto messaggio di congedo, in quel suo “non mi hanno lasciato tagliare le tasse”, si intuisce che il suo successore verrà spinto dai colleghi ad aumentare il disavanzo nel modo più tradizionale: aumentando la spesa, anziché riducendo le tasse. Dato lo stato dei nostri conti pubblici, il ciclo politico, che rischia di essere molto lungo data la minaccia continua di elezioni anticipate, è comunque una sciagura. Non si sa cosa scegliere fra disavanzo con più spesa “per lo sviluppo”, disavanzo con più devolution o disavanzo con meno tasse. Con l’interim di Berlusconi, rischiamo di averle tutte e tre. In questo interim elettorale potremo anche rimpiangere Tremonti.