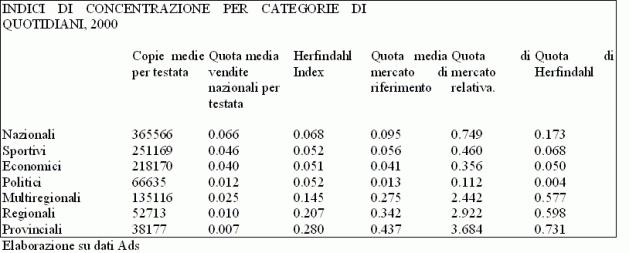E’ stato un anno difficile per i servizi pubblici italiani, e lavoce.info ha cercato di mettere in luce alcuni aspetti critici. Soprattutto la telefonia sembra ancora un mercato ove la concorrenza stenta molto a funzionare, checché ne dica l’impresa dominante… Mentre i trasporti vivono momenti difficili, sia per quanto riguarda il punto di vista deiconsumatori, sia per la crisi pesante di Alitalia, che abbiamo analizzato sotto tanti punti di vista, senza pretendere di “dare una risposta” ma, speriamo, offrendo alcuni elementi di riflessione.
Si parla di impoverimento continuo, di difficoltà delle famiglie ad arrivare alla fine del mese; temi più che rilevanti e preoccupazioni rispettabili. Spesso si incolpa
L’orientamento al mercato
La questione è particolarmente spinosa, poiché da diversi anni a questa parte si è assistito a un processo di graduale liberalizzazione o quanto meno “orientamento al mercato” di molti servizi pubblici. Questa tendenza ha avuto realizzazioni ed effetti diversi nelle diverse utility.
Nella telefonia, ormai siamo di fronte a un mercato dalla parvenze concorrenziali, anche se dominato dal vecchio monopolista. In ogni caso, è un mercato con dinamiche proprie e in forte evoluzione, tanto da meritare un’analisi a parte.
Nel settore idrico, la riforma del 1994 (la “Legge Galli”) ha lentamente portato a superare la frammentazione dei servizi forniti nel territorio, così che quasi in ogni provincia si sta gradualmente giungendo ad avere un unico fornitore di tutti i servizi (acquedotto, fognatura e depurazione).
Liberalizzazione certo non è un’espressione pertinente a descrivere quanto avviene, ma “orientamento al mercato” sì: i sussidi pubblici non sono più accettati, e anzi il prezzo dell’acqua deve salire per coprire il costo dei pesanti investimenti necessari (1) e per incentivare il risparmio idrico a favore delle generazioni future.
Parimenti, nei settori dell’energia, il processo di orientamento al mercato si caratterizza per una maggiore attenzione alla copertura dei costi del servizio attraverso la tariffazione e per una maggiore trasparenza delle tariffe stesse. Qui, tale processo ha toccato soprattutto il segmento all’ingrosso (si pensi ad esempio alla borsa elettrica) ma, comunque, è sempre poca la concorrenza indotta: restano, infatti, posizioni di enorme potere di mercato da parte di Eni ed Enel.
D’altro canto, è anche vero che i conti delle imprese di questi settori, ormai tutte sul mercato azionario, devono rispettare criteri di mercato.
E l’impatto sulle famiglie
Come ha inciso questo processo di riforma sul budget delle famiglie italiane? I cosiddetti “problemi di sostenibilità” nel consumo delle utility di base sono aumentati o diminuiti? Analizzare i dati Istat sui consumi delle famiglie consente di mettere in luce alcuni aspetti di rilievo. (2)
Tra le tre utility “di base” qui considerate, il metano e gli altri combustibili per riscaldamento sono quelle per cui si spende di più: in media circa il 5-6 per cento del reddito delle famiglie italiane. Non gran che, ma tale ammontare varia parecchio da Regione a Regione, in considerazione di vari elementi che determinano effetti contrastanti (tabella 1).
Da un lato, il Nord è più ricco, ma è anche più freddo, e questo richiede maggiori spese per il riscaldamento (non a caso, in Sicilia la spesa per riscaldamento è minima
). Dall’altro, mentre i prezzi dell’elettricità sono uguali su tutto il territorio, quelli del gas e quelli dell’acqua presentano differenze a volte colossali (e non sempre comprensibili). Ad esempio, perché per riscaldarsi una famiglia dell’Emilia Romagna paga il 14 per cento più di una famiglia piemontese? Non certo perché in Piemonte fa più caldo. Si tratta quasi certamente di differenze di prezzo sulle quali occorrerà riflettere meglio.
Anche se si guarda alla percentuale del reddito che si spende per questi servizi, le differenze non riflettono la classica dicotomia Nord-Sud. La Regione ove in media si spende meno (il 4,6 per cento della spesa) è la Sicilia, probabilmente per ragioni climatiche. Quelle ove si spende di più, Basilicata e Calabria (6,6 e 6,9 per cento della spesa): qui il reddito basso non è neppure compensato da condizioni climatiche sempre favorevoli.
Povertà e servizi di base
Tutto questo assume un rilievo particolare quando l’attenzione si concentra sulle fasce più deboli. L’analisi a questo punto si scontra con un limite oggettivo. In Italia non si è mai costruito un indice sulla cui base definire date le condizioni climatiche delle diverse zone del paese quanta energia e quanta acqua dovrebbe consumare una famiglia per condurre una vita, non diciamo agiata, ma almeno sana. Quindi, manca un parametro oggettivo che ci sappia dire cosa significa “povertà” – in senso assoluto – con riferimento al consumo di questi servizi di base (ad esempio, quella che in Gran Bretagna si chiama “fuel poverty”).
A partire dalle informazioni contenute nell’indagine Istat sui consumi delle famiglie è comunque possibile individuare un livello minimo di consumi in utility al di sotto del quale si può parlare di “esclusione sociale”, e valutare che una famiglia incontri problemi di sostenibilità se per assicurarsi questi standard minimi di consumi deve spendere una quota considerata eccessiva del proprio reddito
Seguendo questa logica, si scopre che una quota tra l’11 e il 15 per cento delle famiglie italiane si trova a spendere per il paniere minimo considerato più di questa soglia ovvero ha problemi di sostenibilità della spesa nei servizi di base almeno per una delle tre utility. Questa percentuale è più alta in alcune delle Regioni tradizionalmente povere (Molise, Basilicata, Calabria), ma anche Regioni quali Piemonte o Friuli più ricche, ma anche più fredde mostrano tensioni da non trascurare.
Il processo di liberalizzazione ha acuito il problema? Per questi settori, la risposta per ora sembra essere negativa. La quota di famiglie “sotto stress” non cresce, anzi sembra diminuire. E in realtà se si guarda alla dinamica dei prezzi (figura 1) si vede come gas ed elettricità abbiano una dinamica dei prezzi in linea con l’indice generale dell’inflazione: nonostante l’aumento del petrolio, l’operare dell’Autorità per l’energia almeno fino al 2003 ha saputo proteggere i consumatori.
D’altra parte, i prezzi dell’acqua sono esplosi: +33 per cento dal 1997 al 2003 in termini nominali, circa 15 per cento sopra il tasso di inflazione. E questo è purtroppo solo l’inizio, stanti gli investimenti ingenti che attendono il settore idrico nei prossimi anni. Poiché elettricità e riscaldamento pesano di più nei bilanci familiari, questo significa che in media i consumatori che spendono una quota troppo elevata della loro spesa nelle utility di base sembra diminuire, proprio a partire dal 2001.
Possiamo fare previsioni sul futuro immediato? Sul fronte idrico, le tariffe continueranno a crescere, e su quello energetico presto o tardi le tariffe risentiranno dell’aumento del prezzo del petrolio. E non è certo che le Autorità locali preposte al servizio idrico integrato riusciranno a concordare opportune articolazioni tariffarie con i rispettivi gestori, né che a livello nazionale, per gas ed elettricità – l’attuale Autorità dell’energia sarà in grado di proteggere i consumatori come quella precedente, guidata da Pippo Ranci.
Per ora, in termini di tariffe, le riforme in queste utility sembrano avere funzionato in modo imperfetto, ma almeno ragionevole.
(1) Si stimano pari a 51 miliardi di euro nell’arco di ventisei anni, di cui circa il 45 per cento per acquedotti e il 55 per cento per fognatura e depurazione, (Comitato Risorse Idriche, Relazione al Parlamento sullo Stato dei Servizi Idrici, 2003)
(2) R. Miniaci, C. Scarpa e P. Valbonesi (2004), Restructuring Italian utility markets: household distributional effects.


La liberalizzazione ha trasformato profondamente il settore delle telecomunicazioni, che oggi opera in regime di concorrenza, anche se imperfetta. Un’analisi difficile Effettuare tale analisi è assai arduo. I servizi sono molto differenziati tra loro (chiamate urbane, nazionali e internazionali, le chiamate fisso-mobile, accesso a internet), spesso le tariffe variano con le fascia oraria, e il dedalo delle offerte (con parti fisse o variabili, sconti, offerte speciali e quant’altro), soprattutto nella telefonia mobile, complica ulteriormente la situazione. L’andamento delle tariffe nel fisso
In tabella 1 sono riportati i valori dei canoni mensili dal 1998 al 2003. (1) Un discorso a parte merita il settore della telefonia mobile. Come già detto, i prezzi in questo settore sono particolarmente difficili da analizzare, stante i pochi dati a disposizione. In assenza di un vero e proprio prezzo di riferimento, si può usare come approssimazione il ricavo medio per abbonato (figura 1). Dai dati emerge come esso si sia ridotto nel tempo di circa il 50 per cento, ma anche come dal 2000 a oggi la discesa di questo valore si sia pressoché fermata. Dove sono i benefici per il consumatore Se è vero che non si è qui tenuto conto delle molteplici offerte presenti oggi in Italia, è altresì vero che non si hanno dati certi circa il loro utilizzo nelle famiglie italiane. Quindi, la nostra analisi può considerarsi una proxy del consumatore medio italiano che non necessariamente utilizza offerte speciali. (2) In capo a Telecom Italia vi è l’obbligo di fornire il cosiddetto “servizio universale”, che consiste nell’assicurare l’accesso e l’erogazione di un livello minimo di servizi a tutti gli utenti che ne facciano richiesta, a un prezzo ragionevole e a prescindere dalla loro ubicazione geografica. Storicamente questi costi venivano coperti tramite sussidi incrociati, ossia praticando tariffe superiori ai costi per alcuni servizi (chiamate interurbane e internazionali) e tariffe più basse sui servizi di base. Questo poteva essere sostenibile con un solo operatore, ma con la liberalizzazione alcuni concorrenti sono entrati soprattutto ove i margini di guadagno erano più elevati, e il regolatore è allora dovuto intervenire, attuando il cosiddetto “ribilanciamento” tariffario che ha significato riallineare i prezzi ai costi dei singoli servizi, e anche aumentare il canone. Per maggiori dettagli si rimanda a Cambini, Ravazzi e Valletti, Il mercato delle telecomunicazioni, Il Mulino, 2003.
In attesa che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni renda pubblica la sua analisi di mercato e quindi ci dica se esistono eventuali problemi a cui porre rimedio, cerchiamo di valutare l’impatto che la liberalizzazione ha avuto dal 1998 a oggi sulle tariffe telefoniche e quindi sul consumatore.
Possiamo però dire qualcosa di più preciso sui servizi voce tradizionali (telefonia fissa) e sui ricavi medi per abbonato nel caso della telefonia mobile. Sono i segmenti più tradizionali, ma forse quelli più delicati per valutare se e quanto i piccoli consumatori abbiano beneficiato dalla liberalizzazione.
Ne emerge che a seguito del ribilanciamento tariffario (2) i canoni medi sono aumentati di circa il 20 per cento in cinque anni, con un aumento in termini nominali del 44,2 per cento per il canone residenziale e del 13,8 per cento per quello affari (per il periodo 2000 2004).
Questo pesa soprattutto per le famiglie, per le quali il canone costituisce oggi in media circa il 40 per cento della spesa complessiva, mentre per l’utenza affari incide solo per circa il 18 per cento.
Il peso sempre più rilevante del canone è bene evidente anche nei ricavi di Telecom Italia: dal 2003 i ricavi fissi da canone (pari a 7.870 milioni di euro) hanno superato quelli da traffico (7.116 milioni di euro).
I costi variabili (per minuto) sono invece calati. I prezzi delle chiamate urbane (tabella 2) sono rimasti costanti in termini nominali e quindi si sono ridotti in termini reali, restando per altro sempre inferiori alla media Ue. Sia per le chiamate a lunga distanza (tabella 3) sia per quelle internazionali (tabella 4), i prezzi hanno avuto una consistente riduzione in termini nominali, pur restando in entrambi i casi ben al di sopra della media europea.
In media, quindi, la riduzione delle tariffe per il traffico voce in Italia è stata circa pari al 50 per cento, non distante peraltro dalla riduzione che hanno avuto le tariffe all’ingrosso (- 45 per cento circa) che gli operatori alternativi devono pagare a Telecom Italia per l’accesso alle sue reti.
E nel mobile
Un tale andamento è legato all’esplosione nell’utilizzo del cellulare sia per le chiamate sia per i servizi dati (sms soprattutto) che ha permesso agli operatori di mantenere stabili i propri ricavi per abbonato. Proprio per il fatto che l’Italia è uno dei primi paesi europei per numero degli sms inviati, gli operatori mobili, invece di abbassare i prezzi unitari delle chiamate o guerreggiare su tariffe al minuto più basse, si sono concentrati sull’offerta di pacchetti di servizi sempre più articolati basati sulla possibilità di inviare centinaia di messaggi gratuiti a fronte di un costo fisso.
Il risultato è di rendere il sistema tariffario ancor meno trasparente di quanto poteva esserlo prima, ma questa è un’altra storia.
Se in prima battuta ci si aspettava che la liberalizzazione avrebbe dato ai consumatori finali ampi benefici, forse è bene ricrederci, almeno in parte. Pur nei limiti dei dati disponibili, possiamo infatti concludere che i prezzi unitari dei servizi di telefonia si sono ridotti, ma l’aumento della spesa per il canone fisso è tale da assorbire buona parte di questi benefici.
Nelle stime effettuate da Eurostat ciò è evidenziato in modo significativo.
Considerando un paniere di spesa dei servizi telefonici in modo aggregato – fisso (canone + chiamate) + mobile, utenza residenziale e business -, si può osservare come dal gennaio 1996 al gennaio 2004 l’indice dei prezzi in Italia si è ridotto solamente di 10 punti percentuali in termini reali (si veda LINK BERARDI), molto meno di quanto si è verificato in Francia e Germania, paesi in cui il processo di liberalizzazione è partito allo stesso momento dell’Italia. E non solo: particolarmente preoccupante è il fatto che tale indice sia rimasto pressoché costante dal 2002 a oggi. Che ciò sia dovuto alla presenza di competitori più efficienti o a una regolazione più rigida di quella italiana è difficile da dire. Senza dubbio, ciò mostra che in Italia molto ancora si può e si deve fare per garantire maggiori benefici ai consumatori finali.
(1) Tutti i dati sono stati ripresi dai “Report on the implementation of the Telecommunications Regulatory Package” della Commissione europea pubblicati tra il 1999 e il 2004.

È difficile compiere una valutazione accurata delle prospettive di Alitalia dopo l’accordo con i sindacati. Molti punti cruciali del piano industriale sono ancora poco noti e pende il giudizio della Commissione europea sul riassetto societario e finanziario complessivo del gruppo, in particolare dopo la recente “segnalazione” da parte di otto compagnie concorrenti, secondo le quali il piano sarebbe sorretto da aiuti di Stato. I vincoli della Commissione La Commissione europea aveva condizionato l’autorizzazione all’erogazione del prestito-ponte di 400 milioni di euro (garantito dallo Stato) al varo di un piano credibile per riportare la compagnia in utile dopo dieci anni di bilanci in rosso. Inoltre, aveva vietato ad Alitalia (se si fosse salvata) di accrescere la sua flotta per qualche anno, in modo che non potesse utilizzare i fondi del prestito ponte per potenziare la sua capacità concorrenziale nei confronti delle altre compagnie europee. Allo stesso tempo, la Commissione aveva vincolato l’autorizzazione alla ricapitalizzazione di Alitalia alla riduzione della quota dello Stato nella compagine azionaria al di sotto del 50 per cento. Gli accordi con i sindacati e la parte del Governo La credibilità a breve termine del piano stava quasi tutta nella capacità della compagnia di ridurre il personale (che nei due anni precedenti era cresciuto, nonostante i risultati sempre più negativi) e il costo del lavoro per unità di prodotto, che era il più alto in Europa. (1) Perciò, nella trattativa coi sindacati, l’azienda aveva posto un obiettivo di 5mila esuberi, ma è riuscita a ottenerne soltanto 3.700. Inoltre, aveva chiesto e ottenuto l’azzeramento dei vecchi contratti di lavoro e l’accordo per contratti meno onerosi, con stipendi legati al lavoro effettivo prestato (ore volate, eccetera). Altro punto fondamentale era, per l’azienda, la separazione dei destini della compagnia di volo (AZ Fly) dalle attività di servizio a terra (manutenzione, handling aeroportuale, servizi di informatica, call center e così via), in cui si annidava una parte consistente delle perdite e che dovevano confluire nell’azienda AZ Service. Riassetto societario o aiuti di Stato? Molti dubbi solleva il riassetto societario previsto dagli accordi. Il controllo azionario di AZ Service da parte di AZ Fly (preteso e ottenuto dai sindacati) può indurre a sospettare che non venga reciso il cordone ombelicale tra le due aziende e che, quindi, AZ Fly continui ad “acquistare” servizi inefficienti e a costi superiori a quelli di mercato da AZ Service o che, invece, AZ Service fornisca i suoi servizi sottocosto, sobbarcandosi passivi ingenti. (2) Gli slot, infatti, non vengono messi all’asta ma sono assegnati in base alla regola dei grandfather rights. Questi diritti hanno dunque un valore di mercato proporzionale ai profitti ottenibili sui voli che possono essere fatti grazie a quegli slot.
Un a volta raggiunto l’accordo con i sindacati, il Governo decideva di accordare ai lavoratori in esubero di Alitalia, così come ai loro eventuali colleghi di altre compagnie aeree, l’accesso alla cassa integrazione guadagni, integrata con un fondo speciale per portare i sussidi erogati all’80 per cento dello stipendio. Tale fondo dovrebbe venir alimentato con una piccola “tassa” (circa 1 euro) sui biglietti aerei.
La riduzione degli esuberi rispetto alle richieste dell’azienda può avere diverse letture. Resta comunque il fatto che i minori esuberi implicano una minor riduzione dei costi rispetto al desiderato e quindi per far tornare i conti – la necessità di un maggior incremento dei ricavi. Cosa quest’ultima che implica una riconquista di quote di mercato non facile da ottenere nel quadro fortemente competitivo che si va affermando sulle rotte europee, grazie soprattutto alla presenza aggressiva delle compagnie low cost. Le prospettate alleanze di AZ Fly con altri vettori italiani, però, potrebbero semplicemente tradursi in un aumento del “grado di monopolio” sulle rotte nazionali, ovviamente a danno dei consumatori.
Quanto al nuovo sistema retributivo concordato con i sindacati, sembra di poter dire che esso rappresenti un effettivo passo in avanti verso un assetto sostenibile tanto sotto il profilo dei costi quanto sotto quello della produttività, anche se non è possibile affermare sulla base delle informazioni disponibili in questo momento – che si tratti di un passo decisivo o anche solo sufficiente.
Per la prima volta si è deciso di offrire ammortizzatori sociali estesi a un intero comparto e non limitati all’azienda in crisi. È una novità importante. Tuttavia, la concessione del fondo integrativo appare un pericoloso precedente, soprattutto in quanto destinato a categorie di lavoratori tradizionalmente alquanto privilegiate. La vicenda, inoltre, ripropone l’esigenza di prevedere non nel mezzo di una crisi aziendale o settoriale – un sistema di ammortizzatori sociali equo e generalizzato a tutti i lavoratori.
Non chiaro appare il ruolo attribuito nel piano a Fintecna, che dovrebbe rilevare una quota rilevante (se non addirittura il 49 per cento) del capitale ordinario di AZ Service (e il 100 per cento del capitale “privilegiato”). Perché dovrebbe farlo? E a quale prezzo per ogni azione? Allo stato degli atti non pare che, per Fintecna, un simile acquisto possa costituire un obiettivo strategico. Qualora Fintecna acquisti le azioni di AZ Service solo perché l’azionista di riferimento di Fintecna stessa (cioè il Tesoro) lo impone, e a un prezzo molto più alto di quello di mercato, l’operazione potrebbe configurarsi come una mascheratura di aiuti di Stato. Che potrebbero configurarsi anche se ad AZ Service venisse attribuita una quota molto grande dei debiti pregressi di Alitalia. Ma qui conviene sospendere il giudizio, in attesa di maggiori informazioni sulla natura dell’operazione e del pronunciamento della Commissione europea.
La segnalazione alla Commissione da parte di otto compagnie europee è un segno inequivocabile dell’interesse con cui la vicenda Alitalia è seguita dai concorrenti. È anche un segnale (positivo) che il grado di collusione nel settore si è ridotto (un atteggiamento simile sarebbe impensabile nel settore ferroviario, per esempio).
D’altra parte, date le regole vigenti, i concorrenti possono sempre sperare che il mancato salvataggio di Alitalia sia seguito dalla cessione dell’azienda per un valore pari a quello degli unici asset realmente interessanti che possiede: gli slot aeroportuali e la “designazione” per le rotte intercontinentali più ricche (cioè soprattutto quelle transatlantiche). (2)
Alitalia non è più da tempo un monopolista in Italia, ma detiene pur sempre il 43 per cento del mercato nazionale (aveva il 66 per cento solo nel 2001) e il 22 per cento circa dei voli tra l’Italia e le altre città europee, ma soprattutto è ancora il duopolista leader sulla rotta Milano-Roma, una delle più ricche del continente.
Chi “ereditasse” Alitalia non sarebbe meno ingombrante della vecchia compagnia di bandiera. D’altra parte, le compagnie denuncianti hanno non a caso fatto riferimento alla presenza di un eccesso di capacità nel mercato del trasporto aereo. Il che significa che la scomparsa di un concorrente potrebbe consentire di ridurre la capacità e alzare i prezzi, con improbabili vantaggi per i consumatori. Purché, naturalmente, il salvataggio di Alitalia non sia esso stesso distorsivo della concorrenza, e che il perdurare di una “compagnia di bandiera” in difficoltà non induca il Governo ad atteggiamenti anticoncorrenziali sia nelle scelte di riassetto interno del comparto sia nei confronti di Bruxelles.
(1) Il valore aggiunto per dipendente è passato da 64mila euro nel 1999 a 47mila nel 2003, a causa di una riduzione del valore aggiunto prodotto e di un aumento dei dipendenti da circa 19100 a oltre 20600.
La crisi Alitalia sembra ormai arrivata vicina ad una soluzione. Era chiaro a tutti che o si sarebbe trovato un accordo sul nuovo assetto della compagnia, o il fallimento sarebbe stata l’unica alternativa. E’ da molti mesi evidente come un’impresa che perde oltre un milione di Euro al giorno (
Sul Sole 24Ore del 18 maggio, Carlo De Benedetti osserva giustamente che la nazionalizzazione non può essere la soluzione dei problemi del trasporto aereo in Italia. Una tattica errata La strategia che De Benedetti indica, però, non convince e rischia di suggerire al Governo una tattica sbagliata nella ricerca delle risorse necessarie per risolvere la crisi di Alitalia. Un business plan che punti a rafforzare i collegamenti point-to-point in Europa e nel Mediterraneo, grosso modo sotto le tre ore, non è né necessario né sufficiente. Due esperienze di successo La strada per Alitalia passa necessariamente per la vendita di una quota significativa del capitale (diciamo il 30/40 per cento) a un operatore straniero, cui sia trasferita la gestione operativa del vettore. Emirates ha acquistato 40 per cento di Air Lanka, ribattezzata Srilankan, mentre Klm ha acquisito il 26 per cento di Kenya Airways. Credibilità da costruire L’esperienza di Kenya Airways e Srilankan contiene due messaggi che vale la pena trasmettere a chi ha a cuore l’avvenire di Alitalia. (1) “Il mercato richiede chiarezza”, Il Sole 24 Ore, 18 maggio
Non c’è bisogno di creare una nuova azienda sulle ceneri di Alitalia per permettere alla business community italiana e ai turisti stranieri di viaggiare. Per questo ci sono già i vettori stranieri e le low-cost, comprese quelle italiane che, come Volareweb, stanno già crescendo rapidamente.
Inoltre, a nessun vettore tradizionale, anche ove liberato degli oneri del servizio pubblico, è riuscita la transizione verso un modello di gestione a costi ridotti. Ma se anche questa strategia funzionasse, rischia di non essere sufficiente.
L’esperienza di compagnie europee e asiatiche (spesso pubbliche, come Air France, Emirates o Singapore Airlines) mostra chiaramente come il salto di qualità nei risultati aziendali richiede una strategia aggressiva di sviluppo a partire di un hub efficiente.
Con esso il Tesoro dovrà firmare un chiaro contratto che indichi gli obiettivi strategici: in altre parole, la visione che il Governo ha per la compagnia di bandiera. Non è ragionevole discutere della cessione di una quota di maggioranza: allo stato la compagnia non è un cespite interessante e, soprattutto, la regolamentazione del trasporto aereo internazionale condiziona la designazione di una compagnia nel quadro degli accordi bilaterali alla proprietà nazionale.
Gli esempi cui guardare non mancano, per una volta bisogna però avere l’umiltà di imparare da paesi ben più poveri dell’Italia.
Nel 1996 e 1997, rispettivamente, i governi del Kenya e dello Sri Lanka decisero che l’unica strada per arrestare l’inesorabile declino delle proprie compagnie aeree passava per un accordo con partner esteri disposti a investire risorse, non solo finanziarie, nella difficile missione di trasformare vettori locali privi di una strategia chiara in aerolinee capaci di crescere e sostenere lo sviluppo dell’industria e del turismo.
In ambedue i casi, l’investimento finanziario è stato relativamente modesto, anche perché gli introiti sono andati al fisco, non alla società.L’elemento cruciale è stato il contratto di gestione che ha chiaramente definito gli obiettivi e le responsabilità del nuovo partner.
Nel caso keniota, l’accordo indica come obiettivi aumentare i servizi tra l’Africa e il resto del mondo, condividere risorse, conseguire economie di scala e integrare Kenya Airways nelle alleanze che Klm sviluppa a livello globale. In cambio, Klm nomina i principali dirigenti, ma non la maggioranza del consiglio d’amministrazione, e ha il potere di veto sulle decisioni più importanti.
Anche in un contesto globale di crisi del trasporto aereo, le due compagnie hanno registrato tassi di crescita importanti conseguiti grazie alla razionalizzazione della flotta, alla massiccia introduzione di strumenti informatici per ottimizzare la struttura tariffaria, a una rete di rotte e frequenze capace di supportare lo sviluppo di Nairobi e Colombo come incipienti hub regionali. Il margine operativo lordo è migliorato, il numero di passeggeri e la quantità di merce trasportati sono moltiplicati e ambedue la compagnie accumulano i riconoscimenti internazionali.
Risultati tanto più sorprendenti se si ricorda che Kenya e Sri Lanka sono stati drammaticamente colpiti dall’instabilità politica attentati di Al Quaida a Nairobi e Mombasa, la guerra civile in Sri Lanka e la distruzione di aerei di Srilankan a opera dei terroristi Tamil. Ma ambedue le compagnie hanno ben letto i segnali del mercato. Ad esempio, dopo la conclusione di un accordo open skies con l’India, Srilankan serve quindici destinazioni in quel paese, con l’obiettivo di fare di Colombo un nuovo hub per collegare un mercato di un miliardo di persone con l’Asia e l’Europa.
Il primo, e più immediato, è che l’apertura a capitali esteri migliora la gestione con benefici reali, tra i quali l’aumento della forza lavoro rispetto all’epoca della proprietà pubblica. Non a caso, in ambedue i paesi le relazioni industriali sono ora significativamente migliori di quanto fossero quando la controparte del sindacato era il Governo.
Il secondo è che, in un settore come il trasporto aereo, per consentire questi risultati è necessario che il Governo sviluppi una strategia chiara e credibile. La credibilità si può costruire anche in contesti difficili come quelli di Kenya e Sri Lanka e non dipende necessariamente dalla continuità politica tant’è che in nessuno di questi paesi il Governo che firmò gli accordi con gli investitori stranieri è ancora al potere.
Ma ciò richiede visione e perseveranza nel non capitolare di fronte alle proteste, per esempio quelle che accompagneranno la necessaria scelta dell’unico hub nazionale. Questa è la politica industriale moderna di cui l’Alitalia e il paese avrebbero bisogno.
Malpensa e Alitalia: un rapporto turbolento
Malpensa è stato pensato e costruito come un grande hub. Uno scalo di questo tipo funziona se ricorrono, tra le altre, almeno tre condizioni:
La prima è che ci sia una compagnia aerea di riferimento. Alitalia è, nelle dichiarazioni, questa compagnia. Installata nell’hub di Fiumicino, la compagnia sostiene da anni di voler rafforzare Malpensa. Tuttavia, il personale Alitalia dislocato presso gli scali milanesi (centro di un bacino che vale circa il 70 per cento della domanda di trasporto aereo nazionale) si mantiene intorno a un irrisorio 6,6per cento (1.400 persone su 21.000) e non c’è traccia di progetto per l’installazione di una base di armamento a Malpensa.
Ora, è noto che nessuna compagnia aerea può puntare simultaneamente su due hub, meno che mai Alitalia. Il problema è che la lotta tra romani e milanesi per l’esclusività di Alitalia danneggia tutti, in primo luogo la compagnia aerea.
Una volta tramontata l’ipotesi di fusione con Klm infatti, che proprio in Malpensa trovò il motivo della progettata alleanza e la causa del suo fallimento, il rapporto speciale tra Alitalia e l’hub varesino è finito per sempre. Ed è interesse di tutte le parti in gioco considerarlo reciso una volta per tutte.
La questione di fondo è che in il trasferimento di Alitalia a Malpensa risulta semplicemente impossibile. A parte i costi in questo momento impensabili che la compagnia dovrebbe sopportare per il “trasloco”, Alitalia non lascerà Fiumicino perché è una società romana, nel bene e nel male legata a Roma e al suo milieu politico-economico.
Malpensa solo contro tutti
Una seconda condizione è che esista una serie di aeroporti serventi (Feeding). Si sa che Malpensa ha un nemico in casa: Linate. Un grande aeroporto riceve benefici dalla vicinanza di scali più piccoli a patto che sul primo si concentrino un’importante quantità di voli intercontinentali e che sia ben collegato, anche via terra, con i secondi.
Sotto il primo aspetto, Alitalia ha poche rotte intercontinentali (per di più spalmate tra Fiumicino e Malpensa) e con prezzi medi elevati. Inoltre, trasferire le rotte di Linate su Malpensa sarebbe possibile solo se il progetto incontrasse il consenso di tutto il paese. Ma questo non avverrà, in quanto il centro Sud (ovvero chi prende l’aereo e non il treno per raggiungere il Nord) preferisce (a ragione) volare su Linate, a soli 7 Km dal centro di Milano. Inoltre, i continui conflitti tra i soggetti politico-istituzionali milanesi e lombardi, con la Regione (esclusa dal capitale di Sea) decisamente propensa ad un depotenziamento di Linate e il Comune e la Provincia di Milano fieramente avversi, indeboliscono ulteriormente tale possibilità. Questi elementi, uniti alla questione infrastrutturale, spiegano il fatto che Linate (come altri aeroporti del Nord) funzioni spesso come vero feeding airport di hub europei diversi da Malpensa.
La terza condizione è poi un adeguato sviluppo delle infrastrutture e delle funzioni complementari di terra. Malpensa è sostanzialmente isolato dal suo territorio a causa della mancata attuazione dei piani esistenti per creare un sistema efficiente di infrastrutture stradali e ferroviarie. A questo si aggiunga il fatto che in prossimità dell’aeroporto non si è pienamente realizzato il necessario complesso di funzioni complementari e di supporto alle attività aeroportuali (accoglienza, logistica, ecc.).
Eppure, Malpensa beneficia di una localizzazione straordinaria per la prossimità al nodo di Milano (incrocio tra Corridoio V e Genova Rotterdam, e tra i bracci della grande “T” dell’Alta Velocità italiana) e al mega polo esterno della Fiera.
Inoltre, dal punto di vista tecnico e di pianificazione, esistono tutti gli elementi perché possa decollare lo sviluppo del territorio circostante l’aeroporto (Piano d’area Malpensa) e perché possano essere gradualmente realizzate tutte le infrastrutture di trasporto necessarie (verso Milano e Orio al Serio, il Gottardo e il Sempione, Torino e Genova).
Quale soluzione?
Appare chiaro che la soluzione di questi tre punti è intimamente legata. Solo scegliendo una compagnia di riferimento si potrà ottenere un coinvolgimento dei privati, capace di affiancare un attore pubblico che difficilmente potrà farsi carico interamente del finanziamento delle opere infrastrutturali sopra richiamate.
Non è nell’interesse di nessuno che Alitalia fallisca. E se la compagnia italiana riuscirà ad uscire dalla crisi attuale, sembra destinata a raggiungere l’alleanza franco-olandese. Tuttavia, tale prospettiva pone a Malpensa un problema. La geografia stessa indica infatti che, al di là delle intenzioni di Alitalia, Malpensa sarebbe fagocitato da Parigi Charles de Gaulle: troppo vicini i due aeroporti, troppo bassa la capacità di contrattazione di Alitalia, troppo sviluppato l’hub parigino. Chi si prende dunque il mercato aereo del Nord Italia?
Sulla base di un quadro di fondo così tratteggiato, è possibile ipotizzare schematicamente uno scenario di questo tipo:
– abbandono da parte di Malpensa del legame con Alitalia, in favore di un vettore non continentale e concorrente rispetto agli aeroporti di riferimento dell’alleanza Skyteam e Star Alliance, meglio se asiatico: Malpensa hub europeo di AirChina?
Inoltre:
– definizione del ruolo degli scali dell’Italia del Nord attraverso l’avvio di uno stretto coordinamento tra la Sea e i gestori aeroportuali favorevoli;
– blocco di ogni prospettiva di sviluppo dell’aeroporto di Montichiari come ulteriore hub intercontinentale del Nord e progressiva riduzione di Linate ad aeroporto regionale.
-privatizzazione di Sea, cautelandosi rispetto a acquisizioni da parte dei concorrenti. In presenza di conflitti endemici tra diversi livelli amministrativi e partitici la privatizzazione della Sea, costituisce l’unica via per impostare una strategia di sviluppo svincolata dagli umori politici del momento.
Nel bloccare il salvataggio di Alitalia se veramente è questa la sua intenzione Giulio Tremonti ha ragione; è un atto di serietà. Ma la storia di Alitalia è complessa, e non abbiamo ancora capito come può andare a finire. E occorre proporre qualche alternativa (anche se il “no” è già un buon punto di partenza). La storia di Alitalia, già raccontata anche su questo sito (vedi Ponti), è fatta di perdite che si cerca di tappare con provvedimenti di breve respiro e che ripetutamente la Commissione europea bolla come aiuti di Stato. E quando la società prova a mettere le mani a rimedi strutturali, montano gli scioperi e si cerca la soluzione politica. Ignorando che non c’è soluzione politica che possa consentire a un’impresa di stare su un mercato avendo costi superiori a quelli dei rivali, cambiando piani industriali ogni tre mesi, e fornendo un servizio di qualità ormai percepita dai consumatori come inferiore a quella degli altri. E Alitalia continua inesorabilmente a scivolare su una china in fondo alla quale non ci sono certo posti di lavoro. Quanto costa il servizio pubblico? Poco tempo fa, Mario Sebastiani su lavoce.info ha sottolineato come la privatizzazione totale di Alitalia sia l’unica strada per fare chiarezza, e la chiarezza è fondamentale se vogliamo riportare l’impresa sulla strada dell’equilibrio economico. Non facciamo previsioni
Anche se ritengo questa la soluzione (nel medio periodo) più sensata, non scommetterei un centesimo sul fatto che sarà quella prescelta. Tempo fa, Guido Rossi definiva il capitalismo italiano un capitalismo “straccione”. È vero. Ma è anche un capitalismo sempre assistito e politicizzato. Purtroppo questo è vero per Parmalat (che per anni ha cercato di tenersi in piedi con appoggi politici), per Retequattro (salvata dal satellite dalla legge Gasparri), per le piccole imprese (leggi allevatori e quote latte, o società di calcio). Ed è vero per l’industria pubblica (leggi Alitalia). Ma l’elenco potrebbe continuare. La chiarezza dei conti sembra essere un optional. E lo stesso Tremonti farà fatica a mantenere alta la guardia. Forse non è un caso che proprio un ministro della Lega (Roberto Maroni) preferisca un piano di salvataggio che mantiene l’attuale commistione tra mercato e servizio pubblico, che evita quindi la chiarezza, ma anche ad esempio di comunicare agli elettori del Nord quanto costa servire le zone meno avanzate del paese.
Da un lato, abbiamo rotte che “stanno in piedi da sole”, che sono redditizie e sulle quali Alitalia non avrebbe bisogno di particolari sussidi. Dall’altro, abbiamo rotte che invece vengono servite soprattutto, se non soltanto, per ragioni di equilibrio territoriale, per non isolare le periferie di questo complesso paese (le isole, ma non solo) dai suoi “centri”.
Se le prime possono essere lasciate al mercato, le seconde costituendo un servizio “sociale” dovrebbero essere invece pagate come gli altri servizi sociali di questo paese. Solo che questo richiede, intanto, di far sapere esplicitamente quanto costano, e poi di porre il problema di chi debba pagare per tale servizio. Potremmo magari scoprire che interessa una parte del territorio, ma non il resto. E in periodi di devolution, questi sono temi scottanti.
Si può lasciare Alitalia al mercato? Se si separa ciò che ha senso dal punto di vista della redditività dell’impresa da quanto invece è servizio pubblico, forse sì. O almeno, una volta effettuata tale separazione, se Alitalia dovesse affondare, le rotte non servite da Alitalia sarebbero comunque coperte da altre compagnie, che avrebbero a loro volta bisogno di lavoratori in più, e quindi non sarebbe un problema enorme. Se questa separazione avvenisse, sarebbe il mercato a dire se Alitalia merita di restare in vita, e il paese e i lavoratori andrebbero avanti comunque.
Se questa separazione non avviene, allora Alitalia resterà con un peso (il servizio pubblico in aree non redditizie) che rischia di affondare anche quanto di buono si annidasse in questo carrozzone. E continuiamo a vivere una contraddizione. Da un lato, mettiamo un’impresa nel mercato azionario; dall’altro continuiamo però a gravarla di obblighi simili al “servizio universale” a cui si assoggettano le imprese che vendono acqua, luce o gas, senza però dire chi dovrebbe pagare per tale obbligo. Peggio ancora, questo avviene in un settore che l’Unione europea (non solo la perfida Commissione) ha da tempo dichiarato aperto alla concorrenza, e ove gli aiuti di Stato non sono tollerati.
Come dicevo prima: occorre fare chiarezza. Occorre distinguere ciò che pertiene alla sfera del mercato, e ciò che invece pertiene alla sfera del servizio pubblico. Però per fare questo bisogna avere il coraggio di dire quanto costa servire le isole; quanto costa servire il Sud del paese, e magari convincere la Lega che probabilmente parte di questo deve essere pagato anche dal “Nord”.
Si fa un gran parlare di Alitalia, come se rappresentasse l’unico motivo di preoccupazione del nostro paese in campo aereo. Lo stesso “tavolo” di settore attivato mesi fa dal Governo, iniziativa lodevole in astratto, in definitiva sembra avere come destinatario vero la sola compagnia di bandiera. Ma tutte le compagnie aeree italiane se la passano molto male, troppo piccole per essere competitive. Lo stesso vale per gli operatori aeroportuali, privi di certezze sul loro status, spesso carenti di cultura imprenditoriale e in deficit di trasparenza verso compagnie aeree o passeggeri. Un paradosso italiano Se le difficoltà del settore oggi hanno dimensione mondiale, in Italia assumono un aspetto paradossale. Le potenzialità di crescita della domanda di trasporto aereo sono considerevolmente più elevate che altrove e, diversamente dagli altri aeroporti europei, quelli italiani hanno capacità in eccesso. Esiste dunque una domanda sommersa da sfruttare e infrastrutture sufficienti a sostenerla, per quanto poco efficienti; ma sembra non esistano compagnie nazionali in grado di cogliere questa opportunità. Ha avuto poco coraggio nel presidiare collegamenti in perdita, sottovalutando l’effetto domino, per cui se si abbandona un collegamento si finisce con il perdere traffico anche su altri. E forse c’è stata una certa mancanza di coraggio sul piano del costo del lavoro/sindacale, anche se questo va soprattutto attribuito ai condizionamenti politici. Le due cose hanno interagito, perché le opposizioni sindacali hanno tratto alimento anche dalla sensazione che gli esuberi fossero dovuti al ritirarsi progressivamente da una serie di mercati. Un caso emblematico E allora, perché cambiare cavallo proprio ora? Il motivo è lo stesso che ha decretato il declino della compagnia e del settore da quando la liberalizzazione ne ha rese evidenti le debolezze. Sotto questo profilo l’Alitalia è un caso emblematico dei molti conflitti di interesse che si annidano nei tanti ruoli che lo Stato si trova a svolgere. A cominciare dalla difficoltà di identificare l’azionista pubblico: teoricamente è il Tesoro che dovrebbe avere come obiettivo quello di massimizzare il valore dell’azienda. In realtà è il Governo, la cui collegialità costituisce la stanza di compensazione dei mille obiettivi che si pretende di assegnare alla compagnia. Fatto questo, le relazioni industriali rientrerebbero nella normale dialettica fra le parti sociali. La privatizzazione necessaria In questo contesto una parziale privatizzazione è inimmaginabile: come può esistere un soggetto privato serio (disposto a investire soldi veri) desideroso di entrare in società con lo Stato? Più fattibile una privatizzazione totale: le difficoltà industriali ed economiche della compagnia sono un rischio valutabile, che ovviamente andrebbe scontato dal prezzo, con conseguente sacrificio per l’azionista uscente. Con la privatizzazione sarebbe possibile attivare le alleanze, complemento essenziale per ogni ipotesi risanamento e di sviluppo. È questa la via da seguire anche sul mercato domestico, dove le altre compagnie sono destinate a scomparire se non si va verso una logica di integrazione. Appartiene dunque alla politica europea e nazionale ricercare un nuovo equilibrio fra istanze che appaiono contrapposte, inclusa l’armonizzazione delle discipline e delle prassi antitrust.
Alitalia rappresenta un problema nel problema: costi unitari più elevati, progressivo ritiro da una serie di collegamenti, perdita di quote di mercato su altri, con un circolo perverso attivato dalla tirannia dei costi fissi. E poi c’è Malpensa, hub senza speranze immediate, ma che obbliga la compagnia a dividere la già insufficiente massa critica di mezzi con Fiumicino.
A mio avviso, il management ha lavorato bene, anche se qualche errore lo ha commesso.
Ora il piano Alitalia sembrava andare nella direzione giusta. Nell’arco di un triennio, prevede di abbattere del 18 per cento i costi per posto offerto e di aumentare del 30 per cento la capacità, in parte consistente su collegamenti di lungo raggio. L’introduzione della cassa integrazione è un provvedimento salutare (lo sarebbe per l’intero settore dei trasporti) che può contribuire a sdrammatizzare nell’immediato le tensioni, anche se non risolve i problemi a lungo andare.
Da dieci anni il mercato su cui opera Alitalia è diventato contendibile, ma la società seguita a essere considerata come concessionaria di pubblico servizio, delegata a svolgere ruoli, come venditore e come acquirente di servizi, in nome e per conto dello Stato, entità che da noi è tradotta in “Governo”. Di qui la missione di massimizzare il consenso sociale e territoriale, in base al noto teorema per il quale una società di proprietà pubblica che genera tensioni sociali fa perdere voti nell’immediato, mentre non li fa guadagnare se è in utile, per lo meno non entro un orizzonte temporale rilevante.
E ci stupiamo se gli alleati europei pretendono che la società sia privatizzata prima di costituire un’alleanza? In generale la privatizzazione non è un toccasana, ma nel caso specifico porterebbe a due risultati essenziali:
· tracciare una chiara demarcazione fra i servizi che vanno svolti in regime di mercato (pagano i passeggeri) e quelli da sussidiare (paga la fiscalità generale). Se un’impresa ritiene non conveniente un servizio deve essere libera di sopprimerlo; se altri non subentrano spontaneamente interviene lo Stato con incentivi non discriminatori;
· attribuire alla politica il ruolo che le spetta: indicare le linee industriali del settore (non della compagnia);
E resterebbero distinte due figure che oggi si confondono: gli shareholders dagli stakeholders, posto che oggi gli italiani tutti si sentono azionisti; peggio, si sentono soci di un’associazione da cui pretendono servizi personalizzati.
Naturalmente questo suscita lo spauracchio della mano straniera, della compagnia di bandiera “non più” di bandiera. Per inciso, questo spauracchio è stato agitato anche per altri settori, e la giusta richiesta di reciprocità verso gli altri Stati non sembra essere stata dettata tanto dall’obiettivo di offrire alle nostre aziende le stesso opportunità all’estero che riconosciamo a quelle straniere, quanto dall’inclinazione ad attivare un processo di reciproca interdizione.
Sappiamo bene che su questa strada si va incontro ai rilievi delle Autorità antitrust, in particolare di quella italiana. Ma se è vero che il diritto della concorrenza deve assicurare il pluralismo, è anche vero che se si disconoscono le logiche industriali pluralismo e competitività verranno comunque meno, e con esse lo sviluppo e la tutela degli utenti.
Bisogna promuovere aggregazioni fra le compagnie (sostituire la concorrenza con la cooperazione) fino ad arrivare a pochi gruppi internazionali, ma al tempo stesso creare le condizioni per una concorrenza vera fra i gruppi.
Alitalia perde 50mila euro all’ora. Ma negli ultimi quindici anni ha visto pochi bilanci in attivo, e a volte solo grazie ad artifici contabili. Questo, anche negli anni in cui era monopolista, con tariffe molto alte. Una fotografia della situazione Quanto è costato agli italiani il monopolio in questi anni? Difficile fare i conti: ma poiché le tariffe “low cost” sono circa un terzo di quelle delle compagnie tradizionali, la stima dell’ordine di grandezza è possibile. E si immagini gli effetti sulla crescita complessiva del settore, e dell’occupazione (la domanda è molto elastica alle tariffe). Il settore rimane caratterizzato inoltre da costi elevati sia per i servizi aeroportuali (non liberalizzati nonostante i richiami della Commissione europea) che per quelli del controllo del traffico aereo, mai regolati in modo efficiente. Da notare che la dominanza della compagnia di bandiera (che detiene più del 50 per cento del mercato) genera “scioperi selvaggi”. Tali scioperi in un mercato concorrenziale farebbero rischiare il fallimento della compagnia che non riuscisse a evitarli. Una scelta di sviluppo Che fare ora, con una situazione così deteriorata? La privatizzazione, sempre annunciata e sempre rimandata, sembra indispensabile, per rimettere nella gestione obiettivi di efficienza, “allontanando” le interferenze politico-clientelari. Ma il problema più di fondo, da molti sollevato, è quale politica complessiva perseguire per il settore. In passato, in questo modo non si è generata né efficienza né capacità di competere. Perché dovrebbe accadere ora?
Con l’avvento di una (modesta e incompleta) liberalizzazione, le tariffe hanno iniziato a scendere, e la crisi, già nota e segnalata dagli studiosi del settore, è diventata “conclamata”.
Le cause più evidenti sono da ricercarsi nella bassa produttività del personale e dei mezzi, una politica tariffaria divenuta dinamica solo da poco, una flotta “arlecchino”, con moltissimi tipi di aereo, e alcune scelte incomprensibili (in particolare il trireattore MD11).
Rimangono, poi, importanti segmenti non liberalizzati: i voli intercontinentali e i diritti di atterraggio (“slots aeroportuali”) più redditizi, proprietà esclusiva della compagnie di bandiera. Senza tali protezioni pubbliche (assimilabili di fatto a sussidi), molte compagnie di bandiera sarebbero già uscite da tempo dal mercato, e non solo in Italia.
Nel caso di un produttore dominante paralizzano il paese, e quindi conferiscono un potere improprio per chi li promuove. È esattamente quanto accade nel trasporto pubblico locale, anch’esso caratterizzato da scioperi selvaggi che fermano le città.
Il monopolio quindi non garantisce la pace sociale, anzi si può affermare il contrario.
Il cambio del management ora sembra immotivato (o peggio, ancora motivato da ragioni di controllo politico). Potrebbe essere giustificato solo se il nuovo vertice fosse scelto in base a un piano industriale più convincente di quello ora sul tavolo, ma non ci sono segnali in questo senso.
Le alternative sono sempre le stesse: o una politica “colbertiana”, di rinnovata tutela del “campione nazionale”, o una politica che punta allo sviluppo di un contesto davvero concorrenziale, proteggendo gli utenti invece che i produttori, e favorendo la crescita complessiva del settore.
La prima strada punta a rafforzare le alleanze internazionali. Il loro scopo primario, si badi, non è il bene dei viaggiatori, ma la capacità di premere su Bruxelles per mantenere posizioni di privilegio nelle condizioni di apertura del mercato in corso di negoziato con gli Usa. Si tratta cioè di costituire “compagnie di bandiera europee” al posto di quelle nazionali. Questa strategia comporterebbe poi il mantenimento allo Stato di una “golden share”, che segnali la posizione di privilegio di Alitalia, e lo spostamento dei voli da Linate a Malpensa, in modo da ridurre la concorrenza sui voli intercontinentali, a danno dei milanesi (e delle città del Sud).
La strada alternativa è quella di accelerare la privatizzazione senza “golden share”, e premere sull’Europa perché si acceleri la reale liberalizzazione del settore (l’Italia ha sempre agito in senso contrario, con i risultati che si vedono). La liberalizzazione dei servizi aeroportuali, e una regolazione efficiente delle concessioni (richiesta anche dall’antitrust) e del controllo del traffico aereo dovrebbe ridurre molti costi impropri.
Il settore è in rapida evoluzione con l’avvento delle compagnie “low cost”, che dovranno anche poter oprare sui servizi extra-Europa. Cosa abbiamo da perdere? Perché non scommettere su una Ryanair italiana tra qualche anno?
C’è solo da rammaricarsi che queste cose si scrivevano già cinque anni fa, in un contesto assai meno compromesso.
Le recenti imbarazzanti vicende dell’Alitalia, ma soprattutto i disagi dei cittadini che devono servirsene, sollecitano qualche riflessione di carattere generale sul settore, senza soffermarsi solo su un episodio di ordinario malcostume. Lo scenario L’11 settembre, la guerra irachena, e infine la Sars hanno accentuato una crisi del comparto aereo in atto da tempo su scala mondiale: la United Airlines prossima al fallimento, la Sabena e la Swissair chiuse, Alitalia con bilanci in rosso da un decennio, e il ricorso di molte compagnie di bandiera europee agli aiuti di Stato (ogni volta l’ultimo, si intende). Ma la crisi è crisi delle “grandi compagnie storiche”, perché nel frattempo le nuove compagnie “low cost” sono cresciute e hanno anche realizzato ingenti profitti. E ciò nonostante l’opposizione, oltre che delle compagnie di bandiera “attaccate”, anche dei Governi. E senza risparmi in fatto di sicurezza perché le compagnie “low cost” attribuiscono a questo fattore una priorità molto elevata per la semplicissima economica ragione che nel loro caso un incidente sarebbe sicuramente attribuito dai “media” a insufficiente manutenzione, con conseguenze devastanti. Caratterizzato da crisi profonde anche nei decenni precedenti (si pensi alla scomparsa delle maggiori compagnie “storiche” statunitensi (Twa, Eastern e Pan American), il settore affronta quindi un cambiamento strutturale, seppure ancora in presenza di elevate protezioni per le compagnie maggiori, sia negli Stati Uniti che, soprattutto, in Europa. Il regime degli “slots” (il diritto di operare servizi in certe ore su certe rotte) non è stato mai liberalizzato, così come sostanzialmente rimangono vincolati alle grandi compagnie i servizi intercontinentali (e infatti le compagnie “low cost” non operano in questo campo). Inoltre, sia negli Usa che in Europa permangono vincoli molto stringenti per i regimi proprietari, che sono negati a soggetti “esterni”. Una debolezza strutturale Di questa debolezza strutturale del settore sono state tentate molte spiegazioni. Vediamone due, tanto recenti e accreditate quanto poco convincenti. La prima (cfr. “The Economist” 3-9 maggio 2003) sostiene che il problema è essenzialmente legato a dimensioni aziendali insufficienti: basterebbe accentuare (e consentire) fusioni e concentrazioni per garantire la prosperità del settore (in analogia con quello automobilistico). Ma qui le “economie di scala” hanno un ruolo molto più incerto, come dimostra il fatto che sono le compagnie di maggiori dimensioni ad avere sofferto di più la crisi in Usa (e in Europa). Anche il fenomeno della crescita delle compagnie “low cost” contribuisce a smentire questa tesi. La seconda spiegazione si fonda sui costi eccessivi del carburante, del lavoro, dei servizi aeroportuali, del controllo del traffico aereo, ecc., (cfr. “Volare” maggio 2003), ma la crescita delle compagnie “low cost” sembra indebolire l’argomentazione. Gli aumenti di costi, se reali, hanno colpito tutto il settore: le “low cost” sono sfuggite in Europa solo all’esosità dei grandi aeroporti, ma non alle altre voci, di fatto preponderanti. E comunque non è chiaro perché tali maggiori costi non possano essere trasferiti all’utenza finale, in forte crescita sul lungo periodo (per confermare tale “non trasferibilità”, si ricorda che il settore ha avuto redditività molto modeste fino dagli anni Settanta, pur con crescita impressionante del traffico servito). Sembrerebbe invece che la fragilità del settore sia determinata dalla combinazione di due fattori: caratterizzato da bassi profitti e con una domanda fluttuante nel breve periodo, il settore si dimostra inoltre a offerta rigida, come se prevalessero i costi fissi. In altre parole, sembra che la crisi sia connessa a esuberi di capacità strutturali, anche se periodici. Questa spiegazione si adatta bene all’Europa: grandi compagnie semipubbliche e inefficienti (da cui i bassi profitti), con offerta rigida per ragioni politiche (iper-tutela del lavoro, “immagine nazionale” da sostenere). Ma forse è possibile riscontrare elementi di rigidità dell’offerta anche nelle grandi compagnie americane. Possono essere legati alla necessità del controllo sui segmenti più redditizi della rete (gli “slots” strategici non liberalizzati richiedono la non interruzione, neppure temporanea, del servizio, pena l’avvento di concorrenti. È la logica che discenda da un regime noto come “grandfathers’right”). A ciò si può aggiungere per estensione la necessità del controllo di interi aeroporti “hub” (cioè nodo della rete dei servizi, e spesso sede amministrativa e tecnica della compagnia dominante), come Atlanta, Denver, Chicago. La posizione dominante in un aeroporto ha anche risvolti politici: garantisce posti di lavoro o servizi alla comunità locale che è generalmente proprietaria dell’aeroporto, e che “ricambia” garantendo proprio la dominanza. Ridurre i voli nei periodi di crisi può incrinare le alleanze costituite, aprendo così le porte ai concorrenti (si pensi ai complessi rapporti tra Sea, Aeroporti di Roma e Alitalia, per un esempio più vicino a noi). Il caso Alitalia Per quanto riguarda il nostro Paese, Alitalia è in sofferenza ormai da più di dieci anni, con bilanci in perdita nonostante le elevate tariffe e la protezione di cui gode (slots, voli intercontinentali). La crisi attuale mette in moto pressioni per ridurre alcuni costi (aeroportuali e di controllo del traffico aereo). Sono costi da monopolio naturale che vanno ridimensionati, e di molto, con una buona regolazione pubblica mirata a incentivare drasticamente l’efficienza delle gestioni. In questi giorni il tentativo di riduzione del costo del lavoro, con la contrazione del personale di bordo, ha dato luogo a forme di protesta inaccettabili, indicative di relazioni industriali improprie e tipiche di aziende abituate a regimi clientelari (per inciso, un contesto più concorrenziale ridurrebbe grandemente l’impatto di tali proteste anomale sugli utenti, grazie a un’offerta di servizi meno concentrata). Ma a livello europeo occorrerebbe “approfittare” dell’attuale crisi per liberalizzare il settore, invece che per rafforzarne le barriere monopolistiche (c’è una proposta all’attenzione della Commissione europea di “congelare” gli slots non usati dalle compagnie maggiori, a danno delle compagnie “low cost” che potrebbero accedere a rotte e aeroporti più appetibili). Si potrebbe pensare a sostegni economici (“una tantum” per davvero, questa volta) concordati a livello europeo anche per bilanciare gli analoghi interventi in Usa. In cambio si dovrebbe avviare una reale privatizzazione e apertura del sistema a nuovi soggetti, che già hanno creato grandi benefici agli utenti europei con la loro efficienza. Tali sostegni economici avrebbero il significato di “viatico”, cioè sarebbero connessi alla sostanziale cessazione della presenza pubblica nel settore (se non a fini regolatori a difesa degli utenti), e potrebbero servire anche a tutelare gli addetti delle compagnie che fossero costrette a drastici ridimensionamenti. Infine, la crescita delle compagnie “low cost” significa occupazione e domanda di nuovi aerei, in altre parole uno sviluppo del settore che i grandi “elefanti bianchi” del passato non sembrano più in grado di garantire. A quando una “Ryan Air” italiana?
C’erano una volta le Ferrovie dello Stato. Funzionavano bene o male, a seconda, ma almeno non cercavano di “gabbare” i passeggeri. Ora tutto è cambiato, e forse anche quest’ultima convinzione dovrebbe essere messa in discussione. Permettetemi di raccontare un paio di storie. L’interregionale dei desideri Cerco di fare un biglietto da Pordenone a Brescia. Mi dicono che all’ora che mi interessa devo cambiare a Mestre (vero) e che posso prendere solo l’Eurostar. Obietto: guardi che mi hanno detto che c’è un Intercity. Il bigliettaio mi guarda un po’ torvo, finge di faticare un po’ al terminale, e mi fa il biglietto Intercity (treno che partiva prima dell’Eurostar, si noti.). Stava cercando di farmi arrivare dopo, facendomi pagare più del necessario? Strano. Cerco poi altri treni alla biglietteria automatica, e noto che sistematicamente, per andare da A a B, ti suggeriscono sempre se possibile l’Eurostar o l’Intercity, nascondendo gli interregionali fin quando possibile, ovvero te li propongono per la tratta minima. A ciascuno la sua Divisione La separazione tra chi gestisce la rete (i binari, eccetera, Rfi) e chi gestisce il “materiale rotabile” (i treni, Trenitalia) è nota da tempo, sulla scorta di una qualche moda politica e intellettuale, secondo la quale si può avere sufficiente concorrenza tra diverse compagnie ferroviarie da più che compensare gli intuibili scompensi, frammentazione di responsabilità e così via, che la separazione comporta. Speriamo sia vero. Ogni divisione ha i suoi treni e i suoi centri di manutenzione. In Lombardia, i due centri di manutenzione ancora aperti sono destinati uno ai treni merci (“Divisione cargo”, che meriterebbe un altro articolo), l’altro agli Intercity e Eurostar (della Divisione passeggeri). I locomotori del trasporto regionale vengono sottoposti a manutenzione un po’ da una parte e un po’ dall’altra, “ospiti” delle altre divisioni. Lo stato dei mezzi alimenta il sospetto – che ambienti sindacali non provano neppure a soffocare – che ciascuna divisione privilegi la manutenzione dei propri mezzi, a scapito di quelli regionali. Secondo esempio? Quello dei biglietti. Poiché il grosso delle biglietterie appartiene alla stessa “Divisione passeggeri” insieme agli Intercity, mentre gli interregionali “stanno da un’altra parte”, può capitare (capita spesso) che, appena ci riesce, una biglietteria vi vende un biglietto per l’Intercity e non per il meno costoso interregionale. Non ho nostalgie per il passato, ma si vorrebbe almeno una qualche tutela per i passeggeri.
Esempio? Per andare da Mestre a Treviglio (che è tra Brescia e Milano) si può andare in Intercity fino a Brescia, e poi prendere l’interregionale (che viene da Verona) per l’ultimo pezzetto; oppure prendere l’Intercity solo fino a Verona, e poi salire sullo stesso interregionale di cui sopra fino a Treviglio. Orari di partenza e di arrivo sono gli stessi. Ma la “macchinetta” ti nasconde la seconda combinazione, proponendo solo la prima, che ha una tratta Intercity più lunga, e quindi costa di più. Ripeto: a parità di orari di partenza e arrivo.
Il dubbio che effettivamente stiano cercando di far pagare al cliente più del necessario si rafforza. Esempi di questo tipo, da pendolare “storico” e cliente “affezionato” delle nostre ferrovie ne potrei fare tanti, ma mi sono chiesto se stavo sviluppando una mia paranoia, o se c’era qualcosa di vero in quanto osservavo. E ho cominciato a chiedere.
La cosa meno nota è che in questa riorganizzazione sono state effettuate ulteriori suddivisioni all’interno di Trenitalia, che è articolata non in vere e proprie società, ma in “divisioni”, che non solo non si coordinano come dovrebbero, ma hanno proprio interessi divergenti.
Per quanto ci riguarda più direttamente, da una parte abbiamo la “Divisione passeggeri”, a cui fanno capo tra l’altro Eurostar, Intercity e la maggior parte delle biglietterie; dall’altra, troviamo la “Divisione trasporto regionale”, ove stanno invece i treni regionali e interregionali. A parte il dubbio gusto nella scelta del nome (sono passeggeri pure le persone che viaggiano sui treni regionali) dove sta il problema? Facciamo un paio di esempi.
Infatti, ogni divisione ha i suoi obiettivi distinti di ricavo, e se una di queste biglietterie vende un biglietto per un interregionale invece di uno per Intercity, una parte del ricavato passerà alla “Divisione trasporto regionale”, ovviamente a scapito degli obiettivi di reddito della “Divisione passeggeri”.
Morale? Abbiamo trasformato un’impresa statale che non pareva avere limiti nella capacità di bruciare denaro pubblico in un’impresa che cerca di perseguire l’utile (siamo realisti, basterebbe una riduzione delle perdite) con successi tra l’altro discutibili.
Perfino quelli dei treni locali, che forse non riguardano la “Divisione passeggeri”, ma non sono ancora bestiame.
A quando un’autorità per i trasporti che controlli quello che si sta facendo in questo settore alle spalle degli utenti? Per ora c’è solo una supervisione “tecnica”, effettuata tra l’altro dalla Rete ferroviaria italiana, anch’essa del gruppo Trenitalia.
Se tutti gli altri settori, una volta orientati al mercato, sono stati assoggettati a un controllo indipendente, cosa stiamo aspettando per i trasporti ferroviari?